Quali sono le differenze tra la vecchia e la nuova traduzione del Signore degli Anelli di Tolkien? Qui una guida e la mia opinione.

Ma prima di tutto un disclaimer.
Disclaimer
Questa che stai leggendo è la terza versione di questo articolo.
La prima versione fu pubblicata all’indomani dell’uscita della prima edizione della nuova traduzione del Signore degli Anelli, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.
Siccome all’epoca era uscito solo il primo volume, cioè La Compagnia dell’Anello, era basata solo su quello.
Attirò da subito molti visitatori e siccome l’argomento è estremamente divisivo, generò una quantità notevole di commenti.
Dopo l’uscita delle nuove traduzioni de Le Due Torri e de Il Ritorno del Re, aggiornai l’articolo inserendo le mie impressioni sugli altri due volumi.
Nel frattempo i commenti continuavano a fioccare. Una buona parte consisteva in attacchi al sottoscritto. È stata una faccenda stressante.
C’è chi mi ha accusato di essere aggressivo nelle risposte. Ovviamente chi scorre i commenti non può sapere quanti ne ho cassati perché inopportuni, inconsistenti, ripetitivi e offensivi e difficilmente si rende conto di cosa significhi gestire tutta questa rabbia da parte di perfetti sconosciuti.
Ho deciso di produrre una terza versione di questo articolo dopo alcuni anni, alla luce delle mie riletture della nuova traduzione che, a distanza di tempo e con la mente più fredda, mi hanno permesso di notare problemi che inizialmente mi erano del tutto sfuggiti.
Siccome l’articolo è molto lungo, per agevolare la lettura ho inserito un indice dei contenuti.
Spero di aver fatto un servizio utile a qualcuno.
+++ Fine del disclaimer +++
Indice dei contenuti
2 – Perché è stata fatta una nuova traduzione del Signore degli Anelli
3 – Storia della vecchia traduzione del Signore degli Anelli
3.1 – Il Fantasy in Italia
3.2 – L’Edizione Astrolabio
3.3 – L’Arrivo a Rusconi
4 – I Problemi della vecchia traduzione
4.1 – Gli Errori della vecchia traduzione del Signore degli Anelli
4.2 – Passaggi tradotti troppo liberamente
4.3 – La Filosofia Tradizionalista
4.4 – In che senso fu strumentalizzato il Signore degli Anelli
4.5 – Il Registro mono-tono
4.6 – Perché la vecchia traduzione del Signore degli Anelli contribuisce a strumentalizzare il romanzo
4.7 – Altri pregi e difetti dell’edizione Rusconi
6 – Storia della nuova traduzione del Signore degli Anelli
6.1 – Il Nuovo traduttore e l’AIST
6.2 – Paletti imposti dalla casa editrice
6.3 – Il Coinvolgimento del fandom
6.4 – La Guerra delle Traduzioni del Signore degli Anelli
7 – Perché tutti criticano la nuova traduzione del Signore degli Anelli
7.1 – La Vecchia traduzione è l’unica vera
7.2 – La Nuova traduzione del Signore degli Anelli è stata fatta per motivi politici
7.3 – I Nuovi nomi fanno schifo
8 – Chi ha la colpa di questa guerra?
9 – Analisi della nuova traduzione del signore degli Anelli
9.1 – Errori nella nuova traduzione del Signore degli Anelli
9.2 – I Registri linguistici
9.3 – Un Traduttore non tolkieniano
9.4 – Osservazioni sulle critiche di Ottavio Fatica
9.5 – Le nuove traduzioni dei nomi
9.6 – Analisi di alcuni capitoli
9.7 – Opinione Complessiva
1 – Ci hanno fatto attendere
Credo di aver sentito parlare di una nuova traduzione all’inizio del 2018. Ma dopo alcuni mesi ne avevo perso le tracce, nel senso che chiedendo in giro nessuno sapeva dirmi niente.
A dicembre 2018 incontrai un paio di ragazzi dell’Associazione Italiana Studi Tolkeniani (avevano uno stand alla manifestazione Più libri più liberi, a Roma). Mi dissero che forse sarebbe uscita nel marzo successivo. Ma poi niente. Chiesi un paio di volte alle librerie Feltrinelli di Roma e i commessi mi guardarono come se avessi chiesto un po’ di erba da fumare.
Poi finalmente arrivò la notizia che il 30 ottobre 2019 sarebbe uscito il primo volume della nuova traduzione del Signore degli anelli, La Compagnia dell’anello.
Con mio grande rammarico riuscii a procurarmene una copia solo tre giorni dopo.
Ma perché una nuova traduzione?
2- Perché è stata fatta una nuova traduzione del Signore degli Anelli
Cominciamo col dire che la vecchia traduzione del Signore degli Anelli era una buona traduzione per gli standard dell’epoca. All’estero c’erano stati casi di traduzioni di gran lunga peggiori (in Olanda, in Svezia, in U.R.S.S.).
Ma leggendola oggi, con tutto ciò che sappiamo su Tolkien e considerando che il mondo delle traduzioni si è molto evoluto, appare del tutto inadeguata ai tempi. La vecchia traduzione del Signore degli Anelli conteneva molti problemi: alcuni errori veri e propri, un tono generale appiattito su un unico registro linguistico e frequenti passaggi un po’ troppo liberi, che possiamo definire «parafrasi».
Tali problemi erano ampiamente giustificabili per il contesto in cui quella traduzione era stata prodotta, ma non lo sono più.
Fino a non molto tempo fa, un editore che decideva di portare in Italia un testo straniero aveva soprattutto la preoccupazione di «adattarlo» al contesto culturale italiano e ai gusti dei potenziali acquirenti, che potevano essere molto diversi da quelli del paese di origine.
Mi resi conto di questo leggendo la versione Italiana di un classico della letteratura inglese per ragazzi, «Il Vento tra i Salici» di Kenneth Grahame, con la traduzione a firma di Beppe Fenoglio: una traduzione in italiano elegante e letterario, «adulto», laddove l’originale ha invece un tono semplice e scorrevole, per giovani lettori.
Tolkien amava questo romanzo.
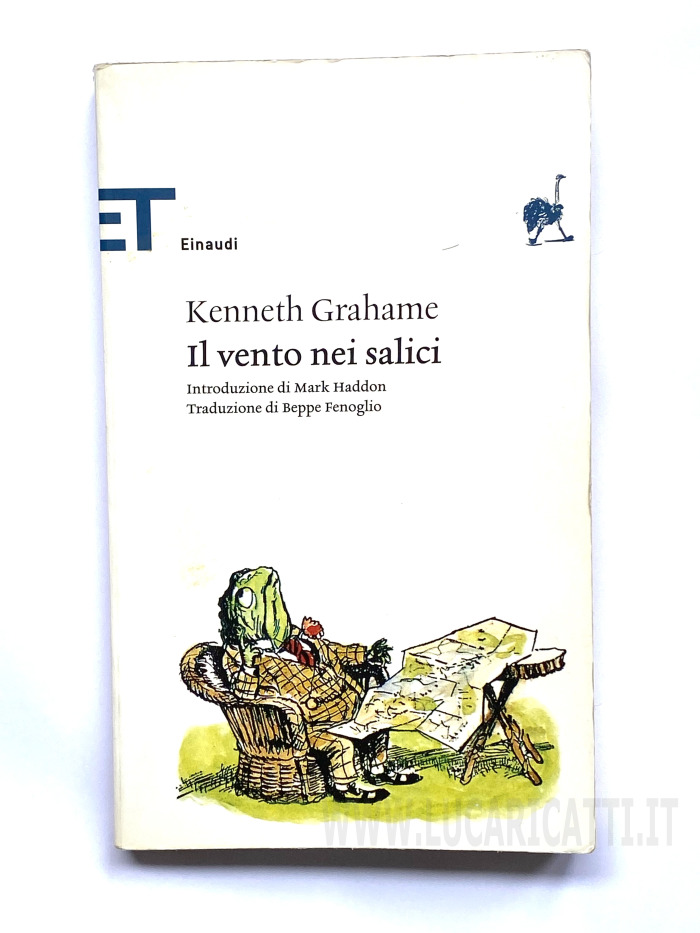
Sospetto che operazioni di questo tipo si facciano anche oggi ma, in generale, il mondo delle traduzioni è molto cambiato. Per esempio non si usa più affidarle a ghost-translator per farle poi firmare a personaggi famosi. I traduttori sono quasi sempre professionisti che hanno seguito precisi percorsi di studio e spesso vengono affiancati da editor e altri esperti.
Oltretutto, il contesto che aveva prodotto la vecchia traduzione del Signore degli Anelli era quantomeno «avventuroso». Infine, il romanzo era sì un libro di culto nel mondo anglosassone, ma non era ancora il grande classico che è oggi. E ai grandi classici ci si dovrebbe accostare con una prudenza che all’epoca non era stata usata.
Oggi il testo di Tolkien è forse il più influente del ‘900, non solo perché considerato punto di riferimento imprescindibile di un genere (epic fantasy), ma anche perché ha condizionato l’immaginario collettivo come poche altre opere letterarie nella storia.
3 – Storia della vecchia traduzione del Signore degli Anelli
Il classico intramontabile del Professor J.R.R. Tolkien (The Professor, per i suoi fan, Tollers per il suoi amici stretti) fu tradotto in lingua Italiana da Vittoria Alliata di Villafranca detta Vicky, nobildonna figlia del principe Francesco Alliata e conosciuta come studiosa del mondo arabo. La Alliata tradusse il romanzo che era una ragazzina, nella seconda metà degli anni ’60: aveva tra i 15 e i 17 anni. Com’è possibile che un editore affidasse la traduzione di un’opera tanto complessa a una studentessa per giunta così giovane?
Non lo sappiamo, ma è possibile che abbia a che fare col fatto che in Italia non ci credeva nessuno, nel fantasy.
3.1 – Premessa: il Fantasy in Italia
Nei paesi anglosassoni c’è una lunga tradizione di letteratura fantastica. I più importanti scrittori che hanno fatto la storia del fantasy, della fantascienza, dell’horror o del weird sono praticamente tutti anglofoni. Tolkien stesso fu un amante della letteratura fantastica fin da giovane. E non fu il primo a inventare storie ambientate in mondi immaginari. Lo avevano già fatto per esempio William Morris, Lord Dunsany o Robert E. Howard (il creatore di Conan il Barbaro).
In Italia non c’è mai stato nulla di simile.
Ricordo un giorno che il mio professore di Storia e Filosofia (ho fatto il liceo nella prima metà degli anni ’90) prese di petto una mia compagna di classe perché le aveva visto in mano una copia di Dracula di Bram Stoker: «Ma che te leggi?!» le gridò scandalizzato.
A me era sempre sembrato un tipo di larghe vedute. Chissà cosa avrebbe detto se avesse saputo che quella mia compagna era fan di Stephen King (fu lei a regalarmi la mia copia di It).
L’atteggiamento del lettore medio italiano verso la letteratura fantastica era di fastidio, derisione, ribrezzo, a volte odio vero e proprio.
Chiarito questo punto, andiamo avanti. Anzi indietro, alla fine degli anni ’60.
L’Italia era molto arretrata culturalmente. La percentuale di analfabeti era oltre il 5% della popolazione, con punte del 20-30% al sud e nelle isole.
Il divorzio divenne legale nel 1970, mentre per l’aborto si dovrà aspettare il 1978.
Il paese era uscito dal secondo conflitto mondiale profondamente diviso, con la Democrazia Cristiana che governava costantemente, alleandosi con chiunque pur di tenere i comunisti all’opposizione; invece la stragrande maggioranza degli intellettuali aveva come punto di riferimento il marxismo e tendeva a interpretare la cultura secondo quegli schemi.
E poi c’erano i neofascisti che facevano capo al Movimento Sociale Italiano.
Ma nel ’68 c’era un grande fermento culturale e i giovani andavano in cerca di nuovi stimoli. Quelli di sinistra furono molto influenzati dalle idee dei filosofi della Scuola di Francoforte, soprattutto Herbert Marcuse, che reinterpretava il marxismo in modo nuovo e criticava tanto il capitalismo americano quanto l’Unione Sovietica. Si dice che l’edizione italiana del suo libro «L’uomo a Una Dimensione» arrivò a vendere 250.000 copie. La sua frase «Immaginazione al potere» divenne uno slogan.
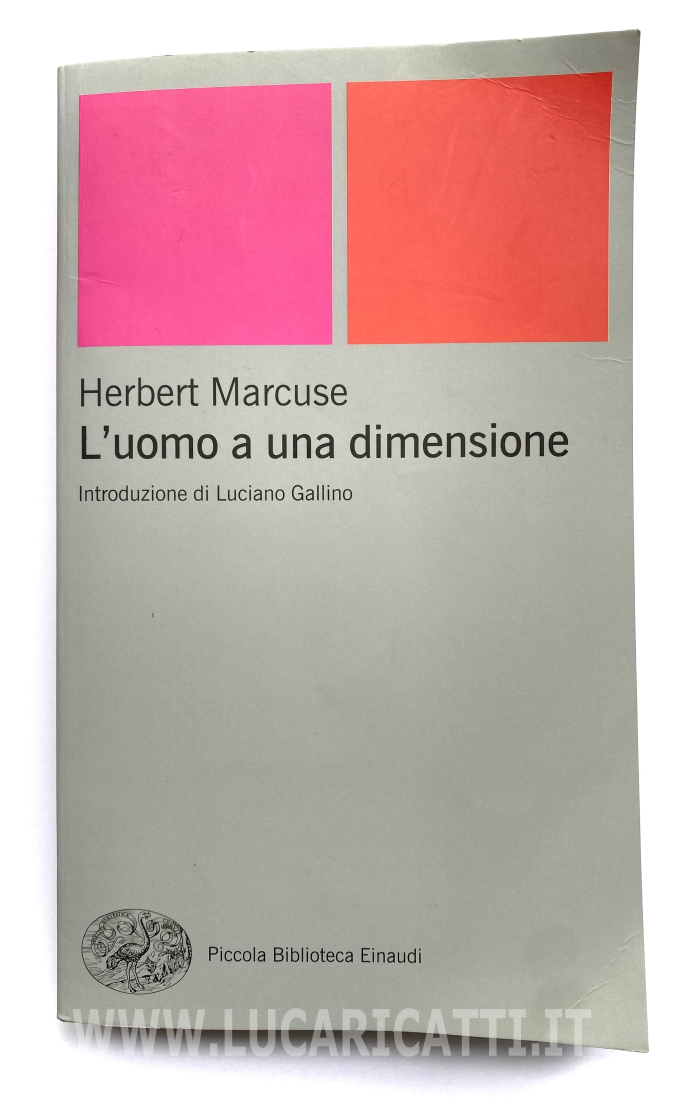
Erano gli anni in cui nacque il movimento ambientalista, era nato il folk revival e c’era interesse verso gli stili di vita alternativi e il contatto con la natura. Tutte cose abbastanza compatibili con l’ambientazione del Signore degli Anelli.
Ma c’è da dubitare che i ragazzi che inneggiavano all’immaginazione avessero influenza sulle decisioni dei grandi editori.
Per la gran parte degli intellettuali italiani, il fantastico era accettabile solo entro stretti limiti, come nel realismo magico (Calvino, Buzzati) o nella letteratura per l’infanzia (Gianni Rodani).
Quando nel’64 la Mondadori chiese un parere su Il Signore degli Anelli allo scrittore Elio Vittorini (che lavorò come consulente per molti grandi editori italiani), questi lo bocciò perché era un’opera «priva di agganci attuali», scritta «senza il genio necessario a garantire il successo». Immagino che ancora oggi i dirigenti di Mondadori lo maledicano in varie lingue.
Non erano solo gli intellettuali marxisti a non capire Tolkien.
Nel rapporto stilato nel 1982 dalla Commissione Moro (composta da deputati democristiani, socialisti, repubblicani e comunisti), a proposito dei Campi Hobbit organizzati dai giovani neofascisti, si dice:
«Il mondo a cui fa riferimento TOLKIEN è un mondo popolato da streghe, gnomi ed orchetti, perennemente in conflitto fra bene e male. La divisione manichea tra il bene ed il male è assoluta ed irriducibile. Il tipo di ideali a cui si rifanno gli attuali “autonomi neri” sono per l’appunto questi: una purezza di per sé rivoluzionaria, un disprezzo assoluto per chiunque non appartenga alla stessa schiera e non ne condivida gli ideali e l’esaltazione della propria individualità nei confronti di un mondo inutile, corrotto e decadente.»
Questo gruppo trasversale di politici dava del romanzo di Tolkien un’interpretazione così sbagliata da essere imbarazzante. Ma, al netto delle idiozie più palesi (streghe e gnomi), era tutto sommato sovrapponibile a quella che ne dava l’estrema destra, come vedremo più avanti.
Contemporaneamente, però, il testo stava già diventando un libro di culto tra i ragazzi d’oltreoceano. Perché criticava la modernità, la cultura delle macchine, l’alienazione dalla natura, la guerra e l’eroismo e aveva come protagonisti esseri semplici che vivevano a contatto con la terra.
Per i ragazzi inglesi e americani era facile: loro sapevano leggere l’inglese.
Gli italiani no.
3.2 – L’edizione Astrolabio-Ubaldini
Vittoria Alliata detta Vicky era una studentessa del Lycée Chateaubriand di Roma, una scuola di eccellenza di lingua francese, era appassionata di lingue ed era molto intraprendente. Ha raccontato lei stessa che, per guadagnare i soldi che le servivano per pagarsi i viaggi all’estero, decise di cimentarsi in una traduzione; aprì le Pagine Gialle e contattò il primo editore in ordine alfabetico: Astrolabio-Ubaldini.
Quelli di Astrolabio le proposero un progetto difficilissimo: tradurre The Lord of the Rings di J.R.R. Tolkien. Lei ha affermato che glielo affidarono perché gli altri a cui era stato proposto avevano rinunciato.
Ad ogni modo, lei, una liceale, tradusse tutto il romanzo.
Purtroppo pubblicarono solo il primo volume. Oggi l’edizione Astrolabio de La Compagnia dell’Anello è introvabile ed è considerata il cimelio dei cimeli tra i fan italiani del Professore.
Le scarse vendite iniziali fecero scoraggiare Ubaldini dal proseguire nell’avventura dell’Anello: la seconda peggiore decisione della storia dell’editoria italiana dopo quella di Mondadori. Ad ogni modo, regalarono tutto il manoscritto della Alliata ad Afredo Cattabiani.
Alfredo Cattabiani era il direttore editoriale di Rusconi. E non era interessato allo strano romanzo del Professore e alla traduzione della ragazzina.
3.3 – L’arrivo a Rusconi
Si dice che sia stato il filosofo tradizionalista Elémire Zolla a convincere Cattabiani.
La cura dell’edizione fu affidata al musicista e saggista Quirino Principe.
Principe va dicendo di aver dovuto lavorare molto sul testo per correggere errori e ricostruire le Appendici: «Fu una fatica capillare». L’ha detto in questa intervista.
Teniamo a mente questa affermazione.
Questa qui sotto è l’edizione in volume unico che hanno in casa la gran parte dei vecchi lettori italiani. È la mia, (tutti i libri fotografati in questo articolo sono miei) ma in realtà io lessi il romanzo su un’edizione molto più vecchia, ereditata; mi procurai anche questa perché originariamente Rusconi non aveva pubblicato alcuna mappa e delle appendici c’era solo quella su Aragorn e Arwen.
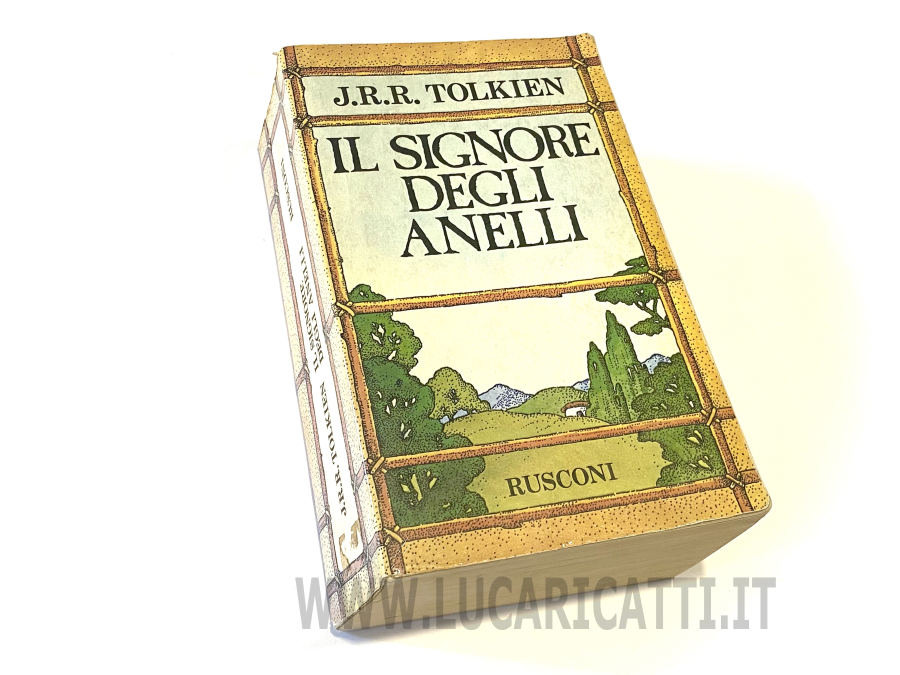
Eppure i problemi in quella traduzione ci sono nonostante l’intervento di (o anche a causa di?) Quirino Principe. Ma la stragrande maggioranza dei lettori italiani (tra cui anche il sottoscritto) non si è posta il problema per decenni.
Gli orchi erano chiamati «orchetti» e i troll erano «vagabondi».
4 – I Problemi della vecchia traduzione
Quando lessi la prima volta il Signore degli Anelli (avevo 20 anni) non riuscivo a capire in che senso dei vagabondi fossero delle creature malvagie ed enormi, trasformate in pietra dalla luce del sole. Ma andiamo con ordine. I problemi della vecchia traduzione del Signore degli Anelli sono:
1) Errori veri e propri
2) Passaggi tradotti troppo liberamente
3) L’interpretazione «tradizionalista»
4) Il registro mono-tono
4.1 – Gli Errori della Vecchia Traduzione del Signore degli Anelli
Nella vecchia traduzione del Signore degli Anelli ci sono alcuni errori veri e propri di traduzione.
Questo non è un resoconto completo di tutti gli errori. Ho elencato solo quelli secondo me più gravi, che non possono essere considerati «traduzioni libere». E ho escluso quelli che a mio avviso potevano essere giustificabili dati gli scarsi mezzi a disposizione alla fine degli anni ’60 (che consistevano solo in un vocabolario): quindi ho escluso i riferimenti al complesso di storie del Silmarillion o espressioni idiomatiche inglesi (che noi oggi possiamo scoprire con una googleata ma che Alliata e Principe potevano non conoscere).
Ovviamente gli errori non li ho scovati io.
La principale fonte che ho preso a riferimento è un documento pubblicato nel 2013 sul sito dell’AIST, consultabile qui ☞errori nelle traduzioni italiane
Questo documento era stato compilato sulla base di notazioni fatte da appassionati italiani. Quindi, tutti gli errori riportati qui di seguito sono da ritenersi frutto di un lavoro collettivo.
Errori ricorrenti
– «Beech»: a me risultano 14 occorrenze di questa parola nel romanzo; per 3 volte è stata tradotta come «betulla» anziché come faggio (Libro Cinque, Cap 9; Libro Sei, Cap 1; Libro Sei, Cap 4).
– Nella vecchia traduzione è stato omesso il termine «heathen», cioè pagani. Questa parola compare solo due volte in tutto il romanzo, ma è importante, perché è un anacronismo voluto da Tolkien e dunque deve essere mantenuto.
– «Shieldmaiden». Ho trovato questo termine 4 volte (una volta nel Libro Cinque Cap. 2 e tre volte nel Libro Sei, Cap. 5). È sempre pronunciata da Éowyn in riferimento a se stessa. Tolkien lo scrive tutto attaccato, ma più spesso si trova scritto shield-maiden. Viene dal norreno skjaldmær, usato per indicare le donne guerriere di epoca vichinga. Sono nominate in varie saghe norrene (ma alcuni storici non sono convinti della loro reale esistenza). Nella vecchia traduzione questa parola è stata resa la prima volta come guerriera, la seconda e la terza come fanciulla d’arme e la quarta come selvaggia fanciulla. È intraducibile in italiano, ma siccome evidentemente Éowyn e Tolkien ci tengono molto, mi sembra giusto tradurla sempre nello stesso modo, così da restituire ai lettori italiani il senso di questa insistenza.
– Le edizioni inglesi che ho consultato scrivono i numeri dei Libri per esteso (cioè in lettere) e i numeri dei capitoli in numeri arabi. Quindi, per esempio, Libro Uno, Capitolo 1.
In tutte le edizioni italiane i numeri dei Libri sono riportati come numeri ordinali e i numeri dei capitoli sono indicati in numeri romani, quindi Libro Primo, Capitolo I.
Altri errori
– Nel prologo c’è la frase: «That story was derived from the earlier chapters of the Red Book, composed by Bilbo himself».
È stata tradotta con Questa storia e’ tratta dai piu’ antichi capitoli del Libro Rosso, scritti da Bilbo in persona. Invece è quella storia.
Nella vecchia traduzione sembra che la «storia» di cui si parla sia il libro che teniamo in mano, ossia il Signore degli Anelli, mentre l’autore si riferisce all’altro libro, cioè Lo Hobbit.
– Nel Libro Uno Cap. 4 compare per tre volte «Golden perch», il nome di una locanda in cui Pippin avrebbe voluto fermarsi a gustare la birra; nella vecchia traduzione del Signore degli Anelli è stato tradotto come «Pertica d’Oro»; ora «perch» significa effettivamente pertica, ma anche persico ed esiste una specie di persico che si chiama proprio golden perch, cioè persico d’oro; si tratta di un pesce tipico dell’Australia, ma secondo gli studiosi il nome della locanda si riferisce proprio a questo, non alla pertica.
– Nel Libro Uno, Cap. 1, compare una Hobbit di nome Melilot Brandybuck, che nella traduzione italiana è riportata come «Melitot» e l’errore è presente anche nell’albero genealogico dei Brandybuck, alla fine delle Appendici; dato che le hobbit hanno spesso nomi di fiori, è un gran peccato che si fosse persa questa sfumatura.
– Nel Libro Uno, Cap. 2 compare la parola «Hundredweight», un’unità di misura che gli inglesi chiamavano anche quintale, ma non corrisponde al nostro quintale (100kg), bensì a 112 libre, cioè circa 50kg. È un gioco di parole scherzoso, perché per festeggiare il centododicesimo compleanno di Bilbo, Frodo aveva preparato una festa chiamandola «Hundredweight Feast» e hundredweight indicava appunto 112.
Nella vecchia traduzione è stato reso con cento chili (la festa dei Cento Chili), perdendo ogni riferimento allo scherzo di Frodo e inoltre sbagliando la conversione della misura. Fermo restando che il gioco di parole è intraducibile, in questo caso si è perso ogni collegamento al numero 112.
– Nel Libro Uno, Capitolo 2 la frase «Bilbo was meant to find the Ring, and not by its maker» era tradotta con Bilbo era destinato a trovare l’Anello, e non il suo creatore; così sembra che Sauron non era destinato a trovare l’Anello; invece il senso della frase è che il creatore dell’Anello (Sauron) non lo aveva realizzato affinché fosse trovato da Bilbo.
– Nel Libro Uno, Cap. 4, Tom Bombadil compare portando una grande foglia come vassoio, sulla quale quale sono posati dei water-lilies, che nella vecchia traduzione erano «candidi gigli»; «lily» è giglio, ma «water-lily» è la ninfea.
– Nel Libro Uno, Cap. 11, Aragorn canta la storia di Beren e Lúthien: nella vecchia traduzione manca un’intera strofa (la penultima).
– Nel Libro Uno, Cap 12, quando i protagonisti incontrano l’elfo Glorfindel, nella vecchia traduzione manca un’intera frase: «Glorfindel caught Frodo as he sank to the ground, and taking him gently in his arms he looked in his face with grave anxiety».
– Nel Libro Due, Cap. 1, quando Frodo incontra Bilbo e questo racconta che stava cercando di terminare di scrivere una canzone, manca un’intera frase: «There will be such a deal of singing that the ideas will be driven clean out of my head».
– Poco dopo, Bilbo si mette a cantare: i versi «he built a boat of timber felled/in Nimbrethil to journey in» (riferiti a Eärendil) sono stati tradotti «Costruì una barca di legno/per recarsi sino a Nimbrethil»; ma il testo inglese dice una cosa tipo «costruì una barca con il legno/abbattuto a Nimbrethil per viaggiarci dentro».
– Nel Libro Due, Cap. 2, Elrond riporta le parole di Isildur, che aveva strappato l’Anello dalla mano di Sauron: «This I will have as weregild for my father, and my brother».
Nella vecchia traduzione la parola «weregild» è stata tradotta come in memoria, che non ha molto senso.
In italiano waregild si dice «guidrigildo»; si tratta di un’istituzione tipica delle popolazioni germaniche, attestata anche nell’Italia medievale: stabiliva il valore di un essere umano e serviva a definire una ricompensa nel caso, per esempio, di omicidio.
Isildur intendeva dire che avrebbe tenuto l’Anello come forma di indennità per la morte del padre e del fratello, non come un ricordo.
Il terminne «weregild» compare anche tre volte nell’Appendice A, sempre tradotto come «ricompensa», che se non altro è più corretto.
Evidentemente, comunque, è meglio usare la corrispondente parola italiana guidrigildo.
– Nel Libro Tre, Cap. 1, quando Aragorn trova Boromir morente, c’è scritto «his horn cloven in two was at his side». Nella vecchia traduzione «horn» è stato tradotto con elmo invece di corno. Il corno di Boromir spezzato in due è un elemento importante nella trama.
– Più avanti, quando celebrano il funerale di Boromir mettendo il suo corpo sulla barca, Aragorn e Legolas intonano un canto funerario e Aragorn dice: «His cloven shield, his broken sword»; questa volta è la parola «shield» ad essere tradotta come elmo invece che scudo.
– Nel Libro Tre, Cap. 5, Quando Gandalf parla di Saruman, dice che «He has no woodcraft»; questa frase è del tutto assente nella vecchia traduzione. «Woodcraft» non ha un corrispettivo in italiano. Questo termine è di solito usato col significato di lavorare il legno, ma qui è messo col significato di capacità di sopravvivere nei boschi, orientarsi, costruirsi attrezzi, cacciare, pescare e cucinare. Al tempo stesso significa anche silvicoltura o comunque prendersi cura dei boschi.
Saruman non ha woodcraft, cioè non saprebbe sopravvivere da solo in un bosco, non ama i boschi, non li capisce, non se ne cura e non li cura, anzi, sappiamo che li devasta, li preda, è loro nemico. È una frase che apre un mondo. Aragorn ha woodcraft, Legolas ne ha a bizzeffe (è un elfo dei boschi), Gandalf certamente sì e anche gli hobbit un po’ ce l’hanno; l’unico che forse ne difetta è Gimli, che però impara ad amare i boschi grazie all’amicizia con Legolas. I difensori della Terra di Mezzo hanno woodcraft, invece i malvagi no.
È certamente molto difficile rendere la ricchezza di significati che si porta dietro questa frase di sole quattro parole. Ma la vecchia traduzione l’ha del tutto saltata.
– Nel Libro Quattro, Capitolo. 4, il titolo del capitolo è inspiegabilmente, «Erbe aromatiche e coniglio al ragù».
Ma il coniglio è «stewed», cioè stufato. La cosa più strana di questa trasformazione è che semmai Sam poteva preparare un ragù di coniglio. Per condirci cosa, però?
– Nel Libro Quattro, Cap. 9, a proposito di Shelob, si dice che lei era «even such as once of old had lived in the Land of the Elves in the West that is now under the Sea, such as Beren fought in the Mountains of Terror in Doriath, and so came to Lúthien». Nel vecchia traduzione è scritto che era lo stesso mostro «che anticamente errava nella Terra degli Elfi in quell’Occidente ormai sommerso dal Mare, lo stesso contro il quale lottò Beren nei Monti del Terrore a Doriath, e che poi in un remoto chiaro di luna si recò a Lùthien».
A parte che Luthien è un personaggio, non un luogo (è stata già nominata da Aragorn nel Libro Uno), il mostro Shelob non è lo stesso, ma è come quelli che vivevano nella Terra degli Elfi. Si tratta di un errore forse giustificabile per una traduttrice non professionista, perché probabilmente dovuto al fatto che il significato di «even» come «simile a» è poco noto. Ma resta un errore.
– Nel Libro Cinque, Cap. 2, Gimli, al seguito di Aragorn che si inoltra sul sentiero dei morti, dice che il sangue gli si gela nelle vene, ma la sua voce si spegne sui «dank fir-needles at his feet». «Fir» è abete, ma nella vecchia traduzione gli aghi umidi ai suoi piedi sono diventati di pino.
– Nel Libro Cinque, Cap. 5, Elfhelm spiega a Merry chi sono i Woses, gli uomini selvaggi dei boschi, e dice che «they are woodcrafty beyond compare». Nella vecchia traduzione è scritto «pare che siano imbattibili nell’arte del legno». Abbiamo di nuovo il termine «woodcraft», che però qui è trasformato in aggettivo mediante l’aggiunta della y finale. Nel Libro Tre Cap. 5 questa parola era stata saltata, qui invece è stata tradotta in modo errato. «Woodcraft» può anche significare lavorare il legno, ma qui evidentemente ha lo stesso significato che aveva nella precedente occorrenza: conoscere i boschi, saperci sopravvivere, amarli e curarli. A detta di Elfhelmm, i Drúedain, chiamati appunto uomini selvaggi dei boschi, hanno woodraft più di chiunque altro. E infatti si schierano dalla parte di buoni.
– Nel Libro Cinque, Cap. 6, Éowyn fronteggia il Nazgûl per difendere il corpo di re Theoden, morente sotto il proprio cavallo, e lo minaccia: «For living or dark undead, I will smite you, if you touch him». Nella vecchia traduzione è stato attribuito «living or dark undead» a Éowyn, anziché al Nazgûl e si è scritto: «Viva o morente ti trafiggerò, se lo tocchi». Va ovviamente attribuito al re degli Spettri, nel senso che Éowyn lo trafiggerà comunque, che lui sia vivo o un oscuro non morto.
– Nel Libro Sei, Cap. 1, nella descrizione della torre di Cirith Ungol si dice che c’erano delle mura merlate «about the lowest tier», cioè all’incirca al livello inferiore; nella vecchia traduzione è scritto «al di sopra del piano inferiore».
– Nel Libro Sei, Cap. 3, Sam vede impotente Gollum che stacca l’Anello a Frodo con tutto il dito e gli sembra che l’Anello «shone now as if verily it was wrought of living fire». Nella vecchia traduzione è stato scritto «Sfavillava come se fosse stato davvero creato nel fuoco vivo», che non ha senso, perché l’Anello è effettivamente stato creato nel fuoco vivo.
La parola wrought secondo me qui è usata in modo molto lirico e difficile da rendere in italiano: letteralmente significa fabbricato, forgiato. Azzardando una traduzione (è solo per rendere l’idea) dovrebbe essere qualcosa tipo brillava ora come se fosse invero appena stato forgiato nel fuoco vivo. Oppure, in modo più libero brillava, come se fosse uscito ora dalla forgia.
– Nel Libro Sei, Cap. 5, quando Éowyn si rende conto di essersi innamorata di Faramir, il testo dice che «Then the heart of Éowyn changed, or else at last she understood it». Nella vecchia traduzione è scritto «Allora il cuore di Éowyn cambiò ad un tratto e fu ella finalmente a comprenderlo», che non sembra avere molto senso. La frase è molto più lineare: il cuore di Éowyn cambiò, oppure lei alla fine lo comprese. .
– All’inizio del Libro Sei Cap. 7, Frodo confessa a Gandalf l’amarezza che lo accompagna nel suo ritorno alla Contea: «for I shall not be the same. I am wounded with knife, sting, and tooth, and a long burden. Where shall I find rest?». Nella vecchia traduzione è scritto: «perché io sono cambiato. Dove troverò riposo?». Manca tutta la parte centrale: sono stato ferito da coltello, pungiglione, dente e un lungo fardello.
– Nel Libro Sei Cap. 7 il titolo è «The Scouring of the Shire». Nella vecchia traduzione è «Percorrendo la Contea». To scour significa ripulire/grattare via/scrostare, quindi va tradotto con qualcosa come La ripulitura della Contea o al limite il repulisti, come nella nuova traduzione.
– In questo Capitolo, il vecchio Gamgee si lamenta del fatto che hanno rovinato le sue «taters», termine colloquiale per indicare le patate. Invece nella vecchia traduzione è scritto che gli hanno rovinato le piante. Non è una pignoleria, le patate sono legate alla famiglia Gamgee: nel Libro Uno Cap. 1 si dice che Bilbo consultava sempre mastro Gamgee in materia di patate e il vecchio giardiniere dice che la gente come lui deve occuparsi di cavoli e patate, altro che elfi e draghi; quando in Ithilien Sam cucina il coniglio, si lamenta di non avere patate da abbinarci. Forse le patate hanno anche un valore simbolico: sono un alimento povero ma nutriente, basilare sia nella cucina britannica che irlandese, oltre che legato alla terra come gli hobbit.
– Nel Libro Sei Cap. 8, quando Sharkey-Saruman estrae un coltello per assassinare Frodo e lo colpisce, nella vecchia traduzione manca la frase «The blade turned on the hidden mail-coat and snapped», cioè la lama si piegò sulla cotta di maglia nascosta e si spezzò. E infatti non si capiva come mai Frodo fosse uscito incolume dall’attentato.
– Libro Sei Cap. 9 c’è forse l’errore più famoso della vecchia traduzione. Verso la fine del capitolo, Frodo deve spiegare a un disperato Sam che lascerà per sempre la Contea e dice: «I tried to save the Shire, and it has been saved, but not for me». Nella vecchia traduzione è scritto: «è stata salvata, ma non per merito mio». Invece il senso è «è stata salvata, ma non per me».
È completamente diverso, anche perché la Contea è stata effettivamente salvata anche per merito di Frodo; ma non per lui, significa che Frodo non può goderne, non riesce a trovare pace nel posto a cui voleva tornare e che amava tanto. In quattro semplici parole c’è tutto il senso di lacerazione tipico dei reduci di guerra.
Ci sono svariati errori anche nelle appendici. Ma siccome ci siamo dilungati davvero troppo, mi limito a segnalare questi due nel Paragrafo 5 dell’Appendice A, quello dedicato alla storia di Aragorn e Arwen:
– Nella parte iniziale Elrond dice ad Aragorn: «A great doom awaits you, either to rise above the height of all your fathers since the days of Elendil, or to fall into darkness with all that is left of your kin». Nella vecchia traduzione è scritto: «Un grande destino ti attende, sia quello di ergerti al di sopra di tutti i tuoi avi succeduti a Elendil, sia quello di cadere nell’oscurità con tutti i superstiti della tua stirpe». Non è sia […] sia, che non ha senso, ma o […] o, cioè una cosa o l’altra.
– Nella parte finale, Arwen è al capezzale di Aragorn morente e, mentre lei lo chiama piangendo, «he took her hand and kissed it, he fell into sleep». Nella vecchia traduzione è scritto: «mentre gli prendeva la mano e la baciava, egli si addormentò». Ma è Aragorn a prendere la mano di Arwen e a baciarla prima di spirare.
4.2 – Passaggi tradotti troppo liberamente
La vecchia traduzione del Signore degli Anelli è quasi sempre piuttosto libera, modifica spessissimo la sintassi originale trasformando lo stile dell’autore, omologando il tono su un livello medio-alto, smorzandone la dinamica e azzerando i toni ironici e sarcastici quando ci sono.
Mi limito a citare qualche esempio per rendere l’idea.
Alcune modifiche sono davvero plateali. Riportiamo un paio di esempi dal Libro Uno.
– Nel Cap. 1, a proposito di suo figlio Sam, il vecchio Gamgee dice che il Signor Bilbo «has learned him his letters». Letteralmente «gli ha imparato» a leggere e scrivere. Questa sgrammaticatura è importante per caratterizzare il personaggio.
Nella vecchia traduzione c’è scritto «gli ha anche insegnato a leggere e scrivere».
– Nel Cap. 5, Pippin si prende gioco di Frodo dicendogli che i suoi amici avevano capito da tempo che aveva intenzione di partire, per via di una serie di comportamenti inspiegabili, tra cui «selling your beloved Bag End to those Sackville-Bagginses!», letteralmente vendere la tua amata Casa Baggins a quei Sackville-Baggins.
Nella vecchia traduzione c’è una profusione di parole: «fino al punto di vendere Casa Baggins, cosi` carica di piacevoli ricordi, a quegli odiosi Sackville-Baggins!».
Ma al di là di questi casi estremi, tutta la traduzione tende a plasmare continuamente il testo, modulandolo su uno tono medio-alto attraverso piccole modifiche della sintassi: viene cambiato il soggetto della frase, semplici aggettivi sono trasformati in forme avverbiali o participi che rendono la prosa «più elegante».
Prendiamo dei brani a caso.
– Incipit del Libro Uno Cap. 1.
La vecchia traduzione è:
Quando il signor Bilbo Baggins di Casa Baggins annunziò che avrebbe presto festeggiato il suo centundicesimo compleanno con una festa sontuosissima, tutta Hobbiville si mise in agitazione.
Bilbo era estremamente ricco e bizzarro e, da quando sessant’anni prima era sparito di colpo, per ritornare poi inaspettatamente, rappresentava la meraviglia della Contea. Le ricchezze portate dal viaggio erano diventate leggendarie, e il popolo credeva, benché ormai i vecchi lo neghino, che la collina di Casa Bagginns fosse piena di grotte rigurgitanti di tesori.
Nella prima frase abbiamo subito un cambio della sintassi: il soggetto dovrebbe essere il binomio talk and excitement (che potremmo tradurre «chiacchiere ed eccitazione»), una squisitezza formale che dà un attacco ironico e leggero; nella vecchia traduzione il soggetto è la città. I talk and excitement, al centro dell’incipit del romanzo, sono spariti.
Nell’originale si dice che che Bilbo era la meraviglia della Contea «since his remarkable disappearance and unexpected return», letteralmente «fin dalla sua notevole sparizione e dal suo inaspettato ritorno». Gli aggettivi remarkable e unexpected sono importanti, perché sono allusioni alle dicerie che circolano su Bilbo: il suo ritorno era «inaspettato» in senso sarcastico, perché era stato dato per morto e un sacco di gente c’era rimasta male a scoprirlo ancora in vita, perché aveva preso possesso delle sue cose (compresa Casa Baggins). Ma il suo tono malizioso viene annacquato con la trasformazione degli aggettivi in avverbi piuttosto scialbi (di colpo e inaspettatamente).
I «viaggi» sono diventati «il viaggio»: certo che era stato uno solo, ma il plurale ha la funzione di riassumere le esagerazioni che circolavano su Bilbo. La «leggenda locale» delle sue ricchezze è diventato «leggendarie».
Nell’originale abbiamo «whatever the old folk might say», letteralmente «qualunque cosa possano dire i vecchi», che è un’altra allusione: evidentemente i vecchi lo negano. La traduzione dice palesemente ciò che doveva essere solo alluso: «benché i vecchi lo neghino». Si è annacquata la malizia della frase originale.
La Collina dovrebbe avere la C maiuscola, ma comunque dovrebbe essere semplicemente «piena» o «stipata», non «rigurgitante», che trasforma un aggettivo in un participio presente ed è un’immagine più letteraria e ben più forte.
– Incipit del Libro Tre, Cap. 1.
La vecchia traduzione è:
Aragorn correva veloce su per la collina, sostando di tanto in tanto solo per chinarsi a guardar per terra. Le impronte degli Hobbit sono leggere e difficili a rintracciarsi anche per un Ramingo, ma non lontano da una cima una sorgiva attraversava il sentiero, e nella terra bagnata vide ciò che cercava.
“Non mi sono sbagliato”, si disse. “Frodo è corso in cima alla collina. Chissà che cosa avrà visto! Ma poi è ridisceso per lo stesso sentiero”.
L’originale ha uno stile da romanzo d’avventura. Getta subito il lettore nel vivo dell’azione. Parte con due frasi brevi e incisive: «Aragorn sped on up the hill. Every now and again he bent to the ground». Ha un ritmo incalzante. Una traduzione letterale sarebbe: «Aragorn accelerava su per la collina. Di tanto in tanto si chinava al suolo». Nella vecchia traduzione, invece, le due frasi sono state separate da una virgola, anziché da un punto, e la seconda frase è stata allungata senza motivo, il che rende l’attacco decisamente più «formale», rispetto al testo di Tolkien, ne rallenta il ritmo e smorza l’emozione con un andamento più descrittivo.
L’elisione della vocale dell’infinito («guardare») non ha molto senso in una prosa di questo genere.
La frase «Hobbits go light», estremamente sintetica, che suona quasi come un motto, è stata resa con un ben più didascalico Le impronte degli Hobbit sono leggere.
Aragorn dice: «I read the signs aright», letteralmente «Ho letto bene i segni». È stato reso con Non mi sono sbagliato, che è una litote, una figura retorica che si usa per attenuare il tono brusco di una affermazione negando il suo contrario; si usa per «ingentilire» una frase. Ma qui non c’è niente da ingentilire, siamo nel vivo dell’azione!
In questo incipit è evidente l’intento di poetizzare un brano di prosa che è ispirato al romanzo di genere, quel tipo di letteratura solitamente considerata di «serie B» e di cui invece Tolkien era estimatore.
La parte finale, poi, è stata del tutto saltata: «and went down the hill again», cioè una cosa del tipo ed è andato di nuovo giù dalla collina.
– Incipit del Libro Cinque, Cap. 1.
La vecchia traduzione è:
Pipino sbirciò da sotto il manto protettivo di Gandalf. Si domandava se era sveglio o se dormiva ancora, trasportato dal rapido sogno nel quale era immerso fin dall’inizio della grande cavalcata. Il mondo buio scompariva veloce ed il vento rumoreggiava nelle sue orecchie. Non vedeva altro che stelle fuggitive, e all’estrema destra, come ombre imponenti, le montagne del Sud. Cercò di ricostruire le tappe del viaggio, e di valutare il tempo trascorso, ma la sua memoria era ancora torbida e incerta.
Qui il testo originale è estremamente lirico, ha un andamento quasi cantilenante e le prime frasi sono piene di allitterazioni («He wondered if he was awake» e «still sleeping, still in the swift-moving»). È certamente molto difficile da rendere in traduzione, ma pare proprio che non si sia neanche tentato.
Questo è un pezzo di grande letteratura, che vuole evocare visioni di sogno attraverso suoni, ritmo e immagini. Le stelle non sono fuggitive ma «whelling», che forse si potrebbe tradurre con vorticanti o qualcosa di simile. Il vento non «rumoreggiava: in inglese è scritto «sang, cioè «cantava/fischiava/sibilava».
Nell’originale abbiamo «vast shadows against the sky where the mountains of the South marched past», letteralmente «vaste ombre contro il cielo dove le montagne del Sud passavano oltre» è diventato solo «le montagne del Sud».
È scomparso sleepily (in modo sonnolento) e reckon the times and stages of their journey (letteralmente calcolare i tempi e le tappe del loro viaggio) si è allungato in ricostruire le tappe del viaggio e valutare il tempo trascorso.
Questi sono gli incipit dei tre volumi del Signore degli Anelli.
Nei primi due, dove il tono è più basso (leggero-comico nel primo e avventuroso nel secondo) la vecchia traduzione usa un linguaggio più paludato, più solenne. Nel terzo incipit, invece, dove il tono dell’originale è molto letterario, la traduzione lo livella verso il basso.
Tutto viene compresso in un tono medio-alto: dove l’originale è basso lo si alza, dove è molto alto lo si abbassa.
4.3 – La filosofia tradizionalista, ovvero usare il potere dell’Anello per i propri scopi
Abbiamo visto che a convincere Cattabiani a pubblicare la traduzione del Signore degli Anelli fu Elémire Zolla. Zolla era un tradizionalista, cioè aderiva alla corrente filosofica del Tradizionalismo Integrale, detto anche Perennialismo, secondo cui (in soldoni) esiste una sapienza universale ed eterna che gli uomini hanno dimenticato ma che può essere riscoperta grazie alle dottrine esoteriche.
Zolla scrisse un’introduzione in cui interpretava Il Signore degli Anelli come una forma di letteratura cavalleresca basata su simboli esoterici.
Di fatto, lo piegava alla propria corrente filosofica (quella tradizionalista, appunto) estranea alle idee di Tolkien.
Quella introduzione è presente in tutte le edizioni della vecchia traduzione Alliata-Principe.
È possibile che anche alla Astrolabio avessero in mente una lettura «spirituale» del Signore degli Anelli: fin dalla sua fondazione, Astrolabio-Ubaldini dedica una grossa fetta del suo catalogo ad argomenti di spiritualità, e religione. Ma alla Rusconi andarono al di là di questo: piegarono letteralmente il significato del romanzo.
Anche il pubblico della Rusconi era composto da persone interessate a testi «spirituali», esoterismo e metafisica, di autori come Ernst Jünger, Mircea Eliade o René Guenon. Infilarono quindi Tolkien in mezzo a queste cose.
4.4 – In che senso fu piegato il significato del Signore degli Anelli?
Per quanto possa suonare strano oggi, per lo meno ai più giovani o a chi non si è mai interessato di certi argomenti, l’esoterismo è da sempre una componente presente nel fascismo, almeno in certe forme di fascismo.
L’argomento fu sviscerato già negli anni ’70 da quella figura geniale e fuori dagli schemi che fu Furio Jesi, in particolare nel testo «Cultura di Destra».
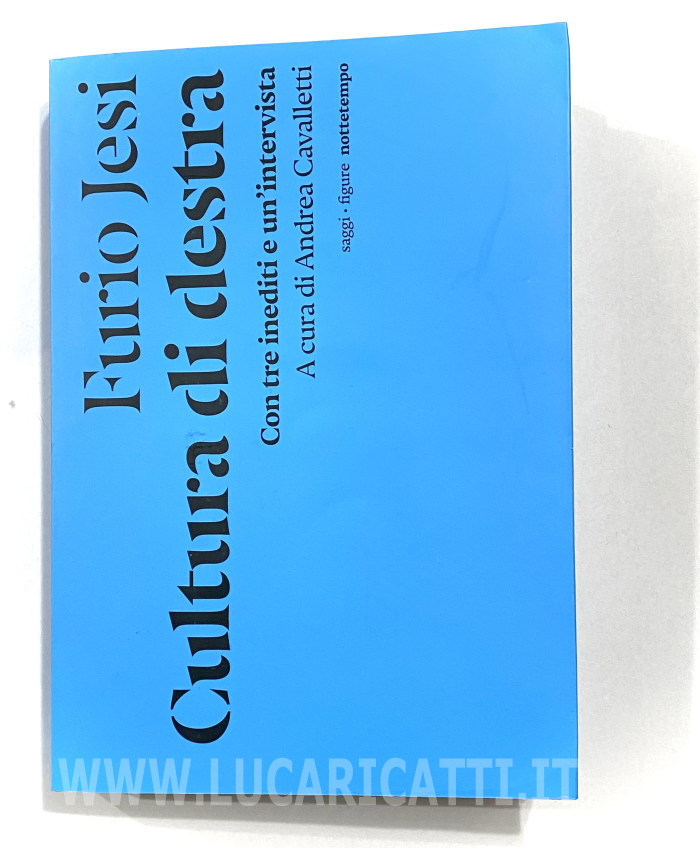
Secondo Jesi molti movimenti e partiti fascisti (come il nazismo, la Guardia di Ferro romena e in parte anche il neofascismo italiano) sono ispirati da una «religione della morte», basata sul sacrificio umano: la morte di avversari politici e di minoranze etniche, ma anche degli stessi adepti (in guerra) permette un avanzamento della razza in senso «spirituale».
Mi scuso per il riassunto estremamente rozzo.
Un altro tema ricorrente in queste forme di fascismo «spirituale» è quello della «decadenza» dell’umanità, che si sarebbe progressivamente allontanata dalla «sapienza primordiale» a causa del progresso.
Queste tematiche provenivano dal filone di studiosi ed esoteristi della corrente tradizionalista come lo storico delle religioni Mircea Eliade (sostenitore della Guardia di Ferro) o Julius Evola (vicino al fascismo italiano e al nazismo), che ebbero grandissima influenza sul neofascismo italiano.
Il segretario del M.S.I. Giorgio Almirante definì Julius Evola «il nostro Marcuse».
E veniamo a Tolkien e all’edizione Rusconi.
Nella sua famosa introduzione Elémire Zolla scriveva che la «fiaba» di Tolkien (i grassetti sono miei):
«non celebra il consueto signore delle favole moderne, Lucifero, ma San Michele o Beowulf o San Giorgio […] egli sta parlando di ciò che tutti noi affrontiamo quotidianamente negli spazi immutevoli che dividono la decisione dal gesto, il dubbio dalla risoluzione, la tentazione dalla caduta o dalla salvezza […] Perché opera di così impalpabili forze The Lord of the Rings si divulgò smisuratamente, senza bisogno di persuasioni o di avalli, perché parlava per simboli e figure di un mondo perenne oltre che araico, dunque più presente a noi del presente».
Queste poche parole, unite ai preconcetti del pubblico italiano sulla letteratura fantastica, bastarono a inserire nel filone del Tradizionalismo l’incolpevole Tolkien, di cui dalle nostre parti nessuno sapeva nulla.
È vero che il tema del sacrificio o quello della decadenza effettivamente ci sono nel romanzo. Ma non nel senso tradizionalista. Tolkien presenta la «morte gloriosa» in modo molto critico (vedi Re Theoden e i suoi nipoti Éomer e Éowyn). La «decadenza» non spinge i protagonisti a una ricerca esoterica per tornare a una presunta sapienza primordiale: il mondo cambia, gli elfi se ne vanno, verranno tempi nuovi e sfide nuove. Per non parlare dei vari discorsi di Gandalf contro l’omicidio e il sacrificio umano (a proposito di Gollum e di Denethor che si uccide sulla pira e che vuole sacrificare suo figlio Faramir).
Tolkien era cristiano cattolico e Il signore degli Anelli ha indubbiamente una forte componente religiosa. Ma non risulta che Tolkien abbia mai pensato al suo romanzo come a una «guida spirituale», né che sia mai stato interessato all’esoterismo.
Charles Williams, suo amico e compagno del circolo letterario degli Inklings, era massone, appassionato di esoterismo e persino iscritto alla congregazione magica della Golden Dawn. Se avesse avuto una propensione per questi argomenti, Tolkien avrebbe potuto approfondirli tramite Williams. Se ne è sempre tenuto lontano.
La chiave di lettura «spirituale» è stata contestata dalla stessa traduttrice Vittoria Alliata, secondo cui Tolkien non ha alcun carattere esoterico. In realtà la Alliata ha affermato di aver voluto dare un tono più «fiabesco» al testo.
Teniamo presente anche questa affermazione.
Ad ogni modo, dopo tanti anni Quirino Principe continua a dare una lettura vicina all’esoterismo, dicendo che Tolkien tenta di «scovare gli archetipi sui quali si regge il mondo» e paragona Il Signore degli Anelli al Faust (!).
Come abbiamo visto, la maggioranza di letterati, editori e politici italiani non era pronta a comprendere un romanzo epic fantasy.
Ma un gruppetto di intellettuali di destra interpretò Il Signore degli Anelli come un’opera che inneggiava ai cosiddetti «sacri valori della Tradizione».
E così lo presentò al pubblico italiano.
Vittoria Alliata ha dichiarato di aver proposto a Rusconi, nel 1996, di rivedere il testo per correggerne gli errori e anche di scrivere una nuova introduzione, ricevendo un rifiuto a entrambe le proposte. Viene il sospetto che, a quasi trent’anni di distanza, alla Rusconi non volevano che si togliesse a Tolkien l’etichetta della «Tradizione».
4.5 – Il Registro mono-tono
Come abbiamo visto, nella traduzione Alliata-Principe veniva appiattito il linguaggio del Signore degli Anelli su uno stile medio-alto, mentre Tolkien varia il registro dal bassissimo (le sgrammaticature di Sam Gamgee e di suo padre) all’altissimo (lo stile aulico degli Elfi e dei Signori e cavalieri di Gondor e Rohan).
Secondo alcuni, a fare la differenza sarebbero stati gli interventi di Quirino Principe. Non so se sia vero, per avere un’idea dell’originale traduzione di Vittoria Alliata bisognerebbe leggere l’edizione Astrolabio de La Compagnia dell’Anello, che purtroppo non ho mai visto.
So per certo che la Alliata aveva tradotto tutti i nomi anglofoni, mentre Principe ne ripristinò alcuni, come Baggins (che nella prima versione Alliata erano «Sacconi»). Ad ogni modo, Principe sembra dare molta importanza al suo intervento sul testo: ha detto che La Compagnia dell’Anello nella edizione Astrolabio «in tre anni vendette soltanto sei copie». «Io partii prendendo come base quello che aveva fatto lei, migliorando, correggendo qualche dettaglio e revisionando le appendici. Divenne un successo».
La dinamica molto ampia di Tolkien va dal linguaggio popolare ai termini tipici dell’antica letteratura anglosassone. Queste variazioni non sono solo forma, sono cariche di significato. Ma nella traduzione Alliata-Principe è sparito tutto, è stato appiattito il testo inglese originale su un linguaggio mono-tono simil epico-cavalleresco.
Questo era funzionale alla sua strumentalizzazione.
A molti questa sembra un’affermazione eccessiva e lo capisco.
Mi spiego.
4.6 – Perché la vecchia traduzione del Signore degli Anelli contribuì a strumentalizzare il romanzo
Prendo a prestito un passo in cui Furio Jesi parla di come l’uso del linguaggio aulico ha spesso una funzione politica (i grassetti sono miei):
«Gli elementi culturali sono per così dire omogeneizzati: in questa pappa, dichiarata preziosa, ma anche ben digeribile da tutta la classe mediamente istruita, non ci sono già veri contrasti, vere punte, spigoli e durezze. […] Questo linguaggio per luoghi comuni di provenienza aulica […] è sfruttabile, ed è generalmente sfruttato, come veicolo dell’ideologia della classe dominante; ma serve a difendere quell’ideologia anche quando non mostra apparenti contenuti ideologici […] È l’elemento più caratteristico della cultura di destra».
Jesi dà una spiegazione molto precisa dell’origine di questo «parlar giusto», questo modo di esprimersi elegante ma piatto, che sa di antico ma al tempo stesso non ha alcun rapporto con la storia. Il succo è che questo linguaggio conferisce autorevolezza perché si richiama a un passato mitizzato e irreale, che ignora i reali fatti storici oppure li deforma. Questo tipo di linguaggio è sempre usato a scopi «reazionari», cioè per difendere il potere e chi lo controlla.
Il linguaggio usato da Tolkien, invece, è completamente diverso.
Nel Signore degli Anelli tutto è collegato ai processi storici.
Lo so che sembra strano, per un romanzo fantasy, ma è proprio così.
Facciamo degli esempi.
La spada di Aragorn non è importante perché è un simbolo tradizionale o un qualche tipo di strumento magico spuntato dal nulla. È la precisa spada (riforgiata) di Elendil, usata da suo figlio Isildur per mozzare il dito di Sauron e sottrargli l’Anello; e l’Oscuro Signore la teme per questo motivo. Inoltre, per Aragorn è una prova materiale di essere il legittimo erede al trono di Gondor. Nel mondo fittizio di Tolkien, la spada del re non è un simbolo, è un oggetto storico.
L’Anello stesso è un manufatto storico. E Gandalf lo scopre a seguito di una lunga ricerca che è a tutti gli effetti la ricerca di uno storico che consulta i testimoni viventi (Bilbo, Gollum, Denethor) e i materiali d’archivio (a Minas Tirith).
Ma Tolkien mette il suo romanzo anche in rapporto con la storia del mondo reale.
I Rohirrim, per esempio, sono modellati sugli antichi anglosassoni e il loro linguaggio e il loro modo di comportarsi non sono ispirati a un «antico» qualsiasi, a un passato non meglio precisato: il loro linguaggio e la loro cultura sono plasmati su quelli dei veri anglosassoni.
Cosa c’entra tutto questo con lo stile e i registri linguistici?
Tutto, perché nel Signore degli Anelli il registro linguistico si incastra costantemente con questi «eventi storicizzati».
Tutto il romanzo può essere interpretato come un viaggio nel passato da parte degli hobbit.
La Contea è plasmata sulla tipica campagna inglese, abitata da borghesi e contadini, dove si beve il tè e si fuma la pipa. E dove si parla l’inglese moderno.
Quando escono dalla loro terra, entrano in un mondo plasmato sul modello dell’alto medioevo, sulle saghe norrene e anglosassoni, dove si parla un inglese più arcaico, basato sulle lingue di quegli antichi popoli.
L’uso della lingua da parte di Tolkien è strettamente legato alla storia, sia a quella di Arda (il suo mondo inventato) sia a quella del mondo reale.
Il romanzo è scritto sempre in lingua inglese, ma l’inglese cambia molto a seconda del contesto. Popoli diversi parlano un inglese diverso. E persone dello stesso popolo possono parlare con sfumature diverse.
Gli Hobbit si esprimono in inglese moderno, ma Frodo, Merry e Pippin, che hanno una buona cultura, parlano in maniera mediamente elegante, mentre Sam, che non è altrettanto fortunato, parla in modo colloquiale e a volte pronuncia errori grammaticali.
Gandalf parla in modo forbito quando interloquisce con elfi e sovrani, ma in modo molto più semplice quando si rivolge agli hobbit.
Vale anche per le descrizioni.
Finché siamo nella Contea prevale l’uso di un inglese moderno, ma quando arriviamo a Lothlórien o a Gondor la lingua del narratore si fa molto più complessa, piena di arcaismi e costruzioni sintattiche ispirate all’inglese antico.
C’è un illuminante saggio scritto da Thomas Honegger, studioso tedesco di letteratura medievale e dell’opera di Tolkien, dal titolo «L’Ovestron tradotto in inglese moderno – i traduttori e la rete di linguaggi tolkieniana». L’articolo si trova tradotto in italiano sul secondo numero dei Quaderni di Arda, rivista dedicata a Tolkien pubblicata da Eterea Edizioni (a cura dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani).
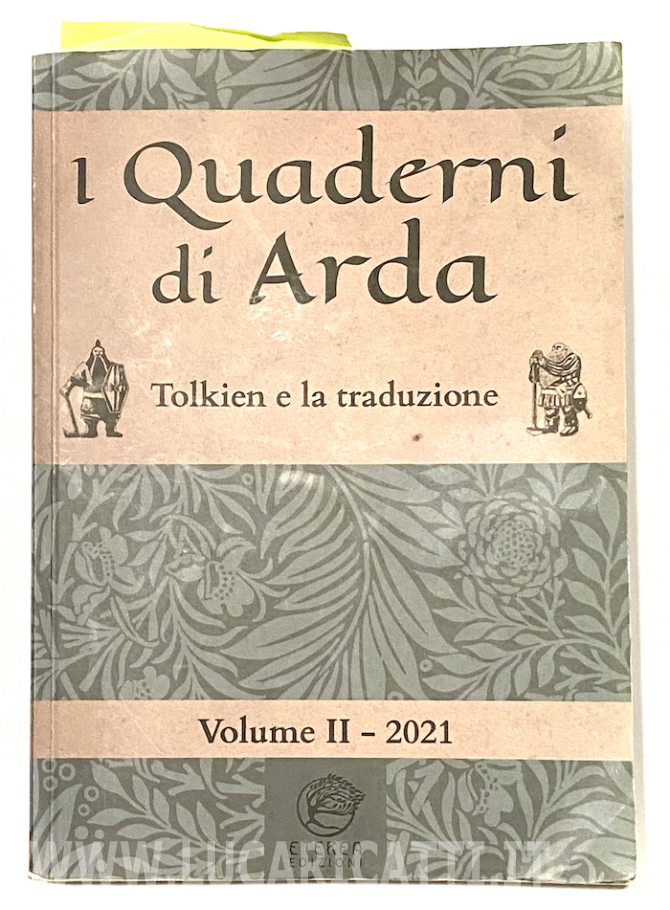
Dice Honegger:
«Un’attenta traduzione in un’altra lingua dovrebbe prendere in considerazione questa differenza di tono e registro, mirando a ottenere l’effetto desiderato anche attraverso l’utilizzo di espressioni dialettali come elemento tipico della parlata hobbit. Tolkien ha utilizzato questa tecnica con una maestria e una coerenza tali che è stato possibile identificare la parlata della Contea con un dialetto della zone dell’Oxfordshire e Warwickshire».
E riporta anche un appunto preso da Tolkien all’epoca in cui stava scrivendo i capitoli ambientati a Rohan:
– Lingua della Contea = inglese moderno
– Lingua di Vallea = norreno
– Lingua di Rohan = anglosassone.
Si vede come la lingua inglese usata da Tolkien è «calata nella storia», la storia di Arda e la storia del mondo reale.
Ovviamente riprodurre differenze così articolate in una traduzione in italiano, una lingua che ha una storia e una struttura molto diverse dall’inglese, è un gran casino. Ma questo non può valere come scusa per omologare tutto.
Invece, il linguaggio della vecchia traduzione del Signore degli Anelli è appiattito su un registro mono-tono e finto-antico, che fa pensare a qualcosa dei secoli passati ma non ha alcun legame con la storia. È proprio quello che Furio Jesi chiamava linguaggio del «lusso spirituale», che serve a richiamare un passato che è una «pappa omogeneizzata» e che non ha alcun legame con la storia. Ed è tutto uguale, nella Contea come a Rohan.
Nella vecchia traduzione non è concepibile che un eroe come Sam Gamgee parli come un esponente della classe operaia. Si arriva all’assurdo per cui Sam si esprime nella stessa maniera di Elrond e di Denethor.
Ecco perché la vecchia traduzione, oltre a tradire il senso del complesso uso del linguaggio di Tolkien, è funzionale alla lettura reazionaria e di destra data dai tradizionalisti della Rusconi.
4.7 – Altri pregi e difetti dell’edizione Rusconi
Va detto che, dopo il fallimento dell’impresa di Astrolabio, se non fosse stato per questi personaggi sarebbero passati molti anni prima di vedere una nuova edizione del Signore degli Anelli in Italia.
Attraverso il pertugio dell’esoterismo di destra, il capolavoro del professore è potuto arrivare a milioni di Italiani.
Al tempo stesso, comunque, Rusconi portava il volume nelle librerie con una fascetta che diceva una cosa tipo:
«Il libro culto degli yippies americani»
Un colpo al cerchio e uno alla botte.
Si cercava di piegare il significato del testo alle idee della destra intellettuale, ma al tempo stesso di piazzarlo anche ai giovani di sinistra.
Come è noto, la fascetta non funzionò: l’Italia divenne l’unico posto al mondo dove Il Signore degli Anelli era considerato un libro da neofascisti.
Sono stato adolescente nella prima metà degli anni ’90, a più di vent’anni dalla prima pubblicazione, e a quel tempo era ancora così che veniva considerato il Signore degli Anelli.
L’edizione Rusconi aveva però una cosa molto bella: le copertine di Pietro Crida.
Per un amante del minimalismo grafico come il sottoscritto, quelle copertine sono state una meravigliosa fonte di ispirazione. Oltretutto mi ricordano lo stile dei paesaggi disegnati dallo stesso Tolkien per Lo Hobbit.
Questa qui sotto è la mia copia di una delle prime edizioni economiche realizzate da Rusconi, risale al 1974.
L’ho ereditata (sono nato tre anni dopo la sua uscita) ovviamene senza la fascetta, di cui ho solo sentito parlare.
È la copia su cui ho letto e amato il Signore degli Anelli la prima volta.
Non so perché il primo volume mi si distrusse tra le mani mentre lo leggevo, invece gli altri due hanno retto piuttosto bene alla prova del tempo.

ATTENZIONE SPOILER: se non hai mai letto il romanzo né visto i film, NON GUARDARE LE PROSSIME IMMAGINI!
La cosa forse più irritante di questa edizione è che spoilerava direttamente nella quarta di copertina.
Cioè, ti rigiravi il libro tra le mani chiedendoti se leggerlo e… ti diceva già il finale!

Come se non bastasse, la famosa introduzione di Zolla entrava ancora di più nei dettagli.
Se prima di iniziare il romanzo leggevi l’introduzione, ti eri giocato tutta la sorpresa.
Io l’avevo letta.

Siamo al totale disprezzo del semplice, meraviglioso piacere del romanzesco.
La Rusconi ha poi passato varie traversie, finché nel 1999 (se non erro) Bompiani acquisì tutto il suo catalogo. Che nel frattempo si era arricchito di altri titoli con la firma di Tolkien.
5 – Arriva Bompiani
All’inizio degli anni 2000, la Bompiani pubblicò un’edizione della vecchia traduzione del Signore degli Anelli riveduta dalla Società Tolkieniana Italiana. La STI vedeva tra i suoi dirigenti persone vicine all’estrema destra e che producevano fra le altre cose materiale sul tradizionalismo e su Julius Evola.
Comunque sia, gli «orchetti» tornavano a essere «orchi» e i «vagabondi» erano di nuovo «troll». Avevano dato una spolverata al vecchio cimelio e l’avevano rimesso in vendita.
Questa è una copia dell’edizione del 2003 in volume unico.
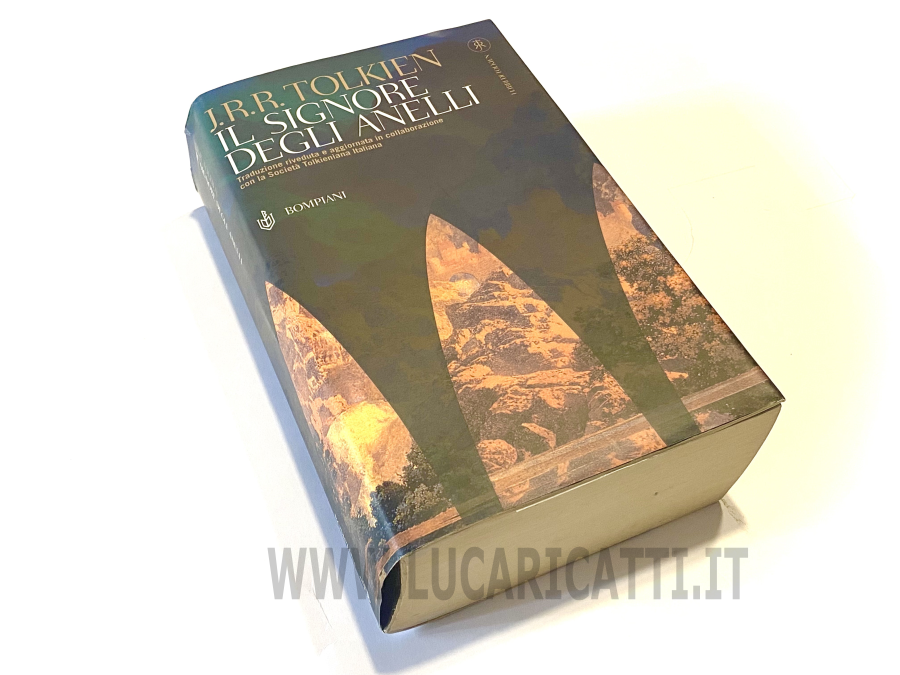
Poi anche la Bompiani passò varie traversie: nel 2015 Mondadori divenne un mega-gigante editoriale acquistando tutta la RCS (di cui faceva parte anche Bompiani).
Giustamente l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) intervenne e obbligò Mondadori a lasciare qualche fetta del mercato anche agli altri.
Così, nel 2016, Mondadori ha ceduto la Bompiani al gruppo Giunti.
In questo nuovo clima, nel 2018, ha iniziato a circolare la voce che Bompiani avrebbe prodotto una nuova traduzione del Signore degli Anelli.
6 – Storia della nuova traduzione del Signore degli Anelli
Dalla Bompiani hanno dichiarato nel gennaio 2019 che l’idea di produrre una nuova traduzione del Signore degli Anelli era maturata perché «da sempre Bompiani lavora a nuove traduzioni di opere di classici e classici contemporanei […] nello spirito di una manutenzione accurata del catalogo».
6.1 – Il nuovo traduttore e l’AIST
La notizia che qualcuno stava lavorando a una nuova traduzione del Signore degli Anelli era stata data ad aprile del 2018. Si disse da subito che ci stava lavorando un traduttore professionista esperto di letteratura inglese (c’è una pagina Wikipedia su di lui ☞Ottavio Fatica). E che alla traduzione aveva collaborato una nuova associazione nata pochi anni prima, la Associazione Italiana Studi Tolkieniani.
Tra le varie cose interessanti che ha fatto l’AIST c’è la fondazione della Tana del Drago, un centro studi su Tolkien nel paese medievale di Dozza (Bologna).

Per realizzare questo centro studi l’AIST nel 2018 organizzò un crowdfunding a cui diedi un microscopico contributo (economico ma anche in termini di pubblicità, parlandone su questo blog), per il quale ricevetti in cambio una maglietta dove mi si conferisce il titolo ovviamente immeritato di founder.

Partecipai alla colletta perché mi piaceva l’idea che persone ben più esperte di me avessero un luogo di riferimento fisico per produrre materiale di qualità su Tolkien e sul fantastico in generale e sono felice di averlo fatto. Purtroppo sono riuscito ad andare a visitare la Tana del Drago solo molti anni dopo (sono di Roma, ho famiglia, lavoro etc.).
A tutti i fan di Tolkien che capitano da quelle parti consiglio di farci un salto.
Tornando a noi, tra i soci fondatori dell’AIST c’erano persone che da anni si interessavano a Tolkien e si erano formati leggendo i testi di celebri critici di fama mondiale, come Tom Sheppey e Verlyn Flieger e che non condividevano l’impostazione italiana tradizionalista.
Ad aderire alla nuova associazione, poi, ci fu il celebre scrittore Federico Guglielmi in arte Wu Ming 4. In particolare, la sola vicinanza del nome Wu Ming è bastata a dare adito a polemiche: non solo perché il collettivo Wu Ming è noto per l’impegno politico a sinistra; Wu Ming 4 aveva pubblicato nel 2013 il libro «Difendere la Terra di Mezzo» in cui ripercorreva la storia editoriale del romanzo. Al centro del volume c’è un capitolo in cui l’autore smonta la lettura simbolista-fascista tipicamente italiana.
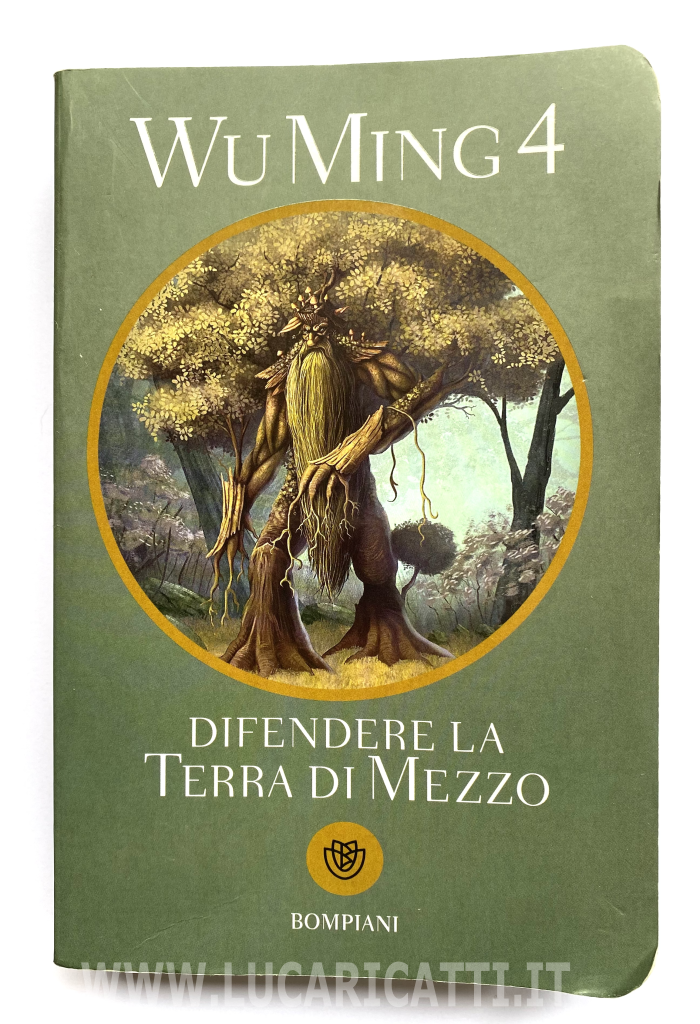
Si tratta di un bel libro, che avevo letto nella prima edizione in formato elettronico (si scarica qui dal sito ufficiale di Wu Ming) e di cui è poi uscita una versione aggiornata e ampliata per Bompiani nel 2023, che ho comprato e riletto.
È una vera pietra miliare della critica tolkieniana in Italia, lo consiglio caldamente.
E insomma, così è scoppiata la Guerra dell’Anello.
6.2 – Paletti imposti dalla casa editrice
Alcuni commentatori hanno avanzato l’ipotesi (mai verificata) che la casa editrice abbia imposto dei paletti riguardo la traduzione dei nomi: alcuni dovevano essere tradotti, altri no, alcuni dovevano essere tradotti ma in modo diverso dalla vecchia traduzione.
Si tratta di voci mai confermate ufficialmente. Mi limito a riportarle perché Ottavio Fatica è stato duramente attaccato per aver modificato i nomi di luoghi e personaggi, ma non possiamo essere certi che si sia trattato sempre di scelte volute da lui.
6.3 – Il Coinvolgimento del fandom
Dopo la prima edizione della nuova traduzione del Signore degli Anelli, tramite l’AIST, sono stati segnalati alla casa editrice una serie di refusi rilevati dai fan. Gli errori sono stati corretti e non sono presenti nelle edizioni successive.
Si tratta di un bel esempio di come la comunità del fandom può essere utile agli editori per alzare il livello qualitativo dell’offerta culturale.
Personalmente apprezzo molto quando le iniziative nate dal basso trovano ascolto fra chi poi realizza materialmente i prodotti culturali.
Penso però che questo ascolto potrebbe spingersi ben oltre e che in questo caso si sarebbe dovuto fare. Ma ne parleremo dopo, a proposito dei difetti della nuova traduzione del Signore degli Anelli di Ottavio Fatica, che comunque ci sono.
6.4 – La guerra delle traduzioni del Signore degli Anelli
In una intervista fatta al Salone del Libro di Torino nel 2018, quando la nuova traduzione era ancora lontana dall’essere pubblicata, il nuovo traduttore Ottavio Fatica disse delle cose poco lusinghiere sulla vecchia traduzione Alliata-Principe.
Parlò di cinquecento errori a pagina. Diceva che non c’era paragrafo senza lacune o sbagli. E faceva riferimento a un’abitudine della Alliata: quella di raddoppiare gli aggettivi:
«Placido e tranquillo, rapido e veloce, misero e magro, crudeli e maligni dove l’originale era feroci. Sembra uno stilema di Tolkien, invece è il suo», diceva Fatica.
La Alliata, giustamente, si è offesa. Ma non ha mandato giù il rospo, ha sporto querela e chiesto alla Bompiani di prendere le distanze da questa denigrazione.
Oltretutto, aveva da poco scoperto che il suo contratto era scaduto dal 2016 (al cambio di proprietà da Mondadori a Giunti). Ne nacque un contenzioso legale.
Alla Bompiani affermarono di aver proposto alla Alliata di rinnovare il contratto e di rivedere la vecchia traduzione, per mantenerla sugli scaffali accanto alla nuova, ma di non aver ricevuto risposta.
Alla fine del 2019, la vecchia traduttrice pubblicò una lettera aperta in cui riassumeva i fatti dal suo punto di vista: diceva di aver ricevuto un’offerta «vessatoria», che consisteva in un compenso di 880 euro annui per il periodo 2016/2019 e una revisione della vecchia traduzione che definisce «sotto tutela», con la quale si sarebbe fatta una nuova edizione che avrebbe incluso una sua introduzione.
A seguito di questa offerta, Vittoria Alliata impose alla Bompiani di ritirare dal commercio tutte le edizioni della sua traduzione, sia cartacee che elettroniche.
Infine, dopo molti rimandi, il 30 ottobre del 2019 la nuova traduzione del Signore degli Anelli è arrivata nelle librerie. Ed è scoppiato un macello.
Nella prima settimana dall’uscita, su Amazon hanno iniziato a piovere recensioni.
E quasi tutte negative.
Tutta gente con tanto tempo libero da poter leggere 200 pagine al giorno?
Ecco qualche screenshot, tanto per capire il tenore.
Alcuni di questi recensori sono reo confessi: hanno letto solo un estratto.



Sembrano prese da un Manuale delle recensioni fasulle. In effetti esiste un manualetto del genere →una pagina Wikihow.
Incredibile come queste ricalchino tutte le caratteristiche delle recensioni false:
☞Brevi
☞Non argomentano e restano piuttosto superficiali
☞Usano termini sensazionalistici («agghiacciante» o «nomi presi da Fantaghirò» o «il traduttore ha fumato oppure ha bevuto»).
Perché questa roba?
A quale scopo queste recensioni farlocche?
Col passare delle settimane, hanno iniziato ad apparire anche molte recensioni positive.
Guarda caso, le recensioni positive sono generalmente piuttosto articolate e dettagliate.
Qualcosa di analogo è capitato a questo articolo: a pochi giorni dalla pubblicazione, hanno iniziato a fioccare i commenti, molti dello stesso tenore delle recensioni negative qui sopra.
Ma perché la nuova traduzione è stata attaccata con tutta questa veemenza? Cos’è stato a scatenare la rabbia dei vecchi fan?
7 – Perché tutti criticano la nuova traduzione del Signore degli Anelli?
Proverò a fare un’analisi delle critiche principali che sono state mosse.
Questa parte dell’articolo è basata soprattutto sulla mia esperienza coi commenti (e gli improperi) ricevuti in questi anni.
7.1 – L’unica vera traduzione è quella vecchia!
Molto spesso si legge in rete che «l’unica vera traduzione del Signore degli Anelli è quella di Alliata», perché sarebbe stata fatta con la «partecipazione del Professore», al quale la ragazza scriveva in caso di dubbi ricevendo sempre risposte puntuali.
A lavoro ultimato, Tolkien avrebbe detto di considerarla «una delle migliori traduzioni realizzate».
Purtroppo la fonte di queste informazioni è la Alliata stessa, infatti non esiste alcun riscontro scritto, né altre testimonianze. Magari un domani spunterà fuori qualche tipo di prova, sarebbe una perla inestimabile per i fan italiani, chi può dirlo.
Resta il fatto che alcuni ammiratori considerano la vecchia traduzione l’unica degna di esistere, sulla base di queste affermazioni della vecchia traduttrice.
Consideriamo però la cosa con un po’ di obiettività.
La traduzione Alliata è scritta in un italiano elegante e fluente. Ed era l’unica traduzione in lingua italiana mai fatta.
Oltretutto, Tolkien veniva da alcune esperienze tragiche, come la prima traduzione in svedese fatta da Åke Ohlmarks, personaggio controverso che Tolkien considerava «un uomo molto presuntuoso» (lettera 204), la cui versione è considerata una parafrasi totale o quasi. Qualcosa di simile era capitato con l’olandese.
È piuttosto comprensibile dunque che la traduzione in un buon italiano, abbastanza aderente al testo (per gli standard dell’epoca), fatta da una giovane studentessa italiana colta, perspicace e bendisposta verso l’autore lo avesse soddisfatto.
Questo significa che non se ne possono fare altre? O che sia la migliore possibile?
Inoltre, nessun classico della Letteratura viene tradotto una volta e poi basta.
Quante traduzioni in italiano sono state fatte di Shakespeare? O dei poemi omerici?
Tolkien stesso sosteneva l’importanza di ritradurre continuamente i classici!
Forse fra altri cinquant’anni i giovani italiani troveranno la traduzione di Ottavio Fatica vecchia e improponibile. Forse esisteranno altre decine di traduzioni. E forse non interesseranno a nessuno perché tutti leggeranno fluentemente l’inglese.
7.2 – La nuova traduzione del Signore degli Anelli è stata fatta per motivi politici?
Un’altra affermazione che ho trovato spesso in rete (anche tra i commenti a questo articolo) è che la nuova traduzione del Signore degli Anelli è stata fatta per motivi politici.
Una frase che può significare diverse cose.
Significa che è stata fatta per togliere alla destra il monopolio di Tolkien in Italia?
Prima di tutto, ci sono buoni motivi per credere che il monopolio della destra sul Signore degli Anelli scricchiolasse già da anni: da quando Tolkien è diventato un fenomeno pop, in seguito all’uscita della trilogia cinematografica di Peter Jackson.
Ad ogni modo, la nuova traduzione del Signore degli Anelli (che non è accompagnata da nessuna introduzione, a differenza della vecchia traduzione), è nata allo scopo di avere una versione italiana più corretta e aderente al testo originale. L’uscita dalla nicchia della destra tradizionalista, semmai, è un effetto secondario, dovuto al fatto che nessuno cerca più di strumentalizzare l’opera di Tolkien.
Significa che è stata fatta per far apparire Tolkien e la sua opera «di sinistra»?
Chi avrebbe avuto interesse a fare un’operazione del genere?
La Bompiani?
E perché alla Bompiani dovrebbero impelagarsi in una simile follia? Sarebbe una mossa suicida dal punto di vista sia commerciale che della credibilità come operatore culturale.
Sono stati quelli dell’AIST?
Mi pare improbabile, anche perché l’AIST ha avuto solo un ruolo di consulenza, non ha avuto alcuna responsabilità o possibilità decisionale nelle scelte finali dell’editore. In pratica l’AIST ha dato solo alcuni pareri tecnici al traduttore, che poi però ha fatto quello che voleva lui.
Allora è stato Ottavio Fatica?
Non ho idea di quali siano le preferenze politiche di Ottavio Fatica, ma perché avrebbe dovuto fare una cosa così folle, che gli avrebbe probabilmente distrutto la carriera? E nessuno nella casa editrice si sarebbe accorto di questo suo sabotaggio?
Ma anche volendo, per trasformare il testo in modo da farlo sembrare «di sinistra», si dovrebbe fare qualcosa di simile a quello che si era fatto con la vecchia traduzione (che, quella sì, lo faceva sembrare «di destra»): inserire una introduzione con una forte connotazione politica e fare una traduzione manipolatoria del testo.
Non è obiettivamente stata fatta nessuna delle due cose.
Significa che si è voluto adattare il romanzo alla «cultura woke» e al «politicamente corretto», in nome della «cancel culture»?
Un’obiezione simile è stata mossa, tra gli altri, da Vittoria Alliata e dal suo intervistatore Oronzo Cilli in un articolo su Il Giornale; tra l’altro hanno fatto queste affermazioni prima che la nuova traduzione fosse pubblicata (ne parliamo sotto).
È falso, non c’è stata alcuna manomissione del testo originale, nessuna frase cancellata o doppi sensi inseriti o rimossi. La nuova traduzione del Signore degli Anelli è stata letta da molti studiosi italiani di Tolkien e da migliaia di fan, compresi i suoi detrattori: nessuno è stato in grado di rilevare alcuna modifica o cancellazione del testo originale.
7.3 – Perché i nuovi nomi fanno schifo!
Fin dall’uscita della nuova traduzione del Signore degli Anelli, la questione dei nomi cambiati è stata al centro delle polemiche.
Per la mia esperienza con questo articolo, nella prima fase gli attacchi alla nuova traduzione erano di segno politico: i fan italiani di destra si sono sentiti «derubati» del loro «testo sacro» e, non avendo altri appigli, (perché non l’avevano letta) hanno aggredito l’operazione editoriale attaccandosi alla faccenda dei nomi.
Con il tempo, però, anche tantissimi lettori non-politicizzati si sono lamentati dei nomi cambiati, soprattutto perché, a detta loro, sono stati cambiati in peggio.
Il mio parere su questa faccenda lo rimando alla sezione in cui parleremo dei difetti della nuova traduzione. Per ora dico solo che i nomi non sono stati affatto cambiati in peggio. Il problema è che i vecchi nomi sono quelli usati nei film di Peter Jackson, cioè sono parte integrante della «pop-izzazione» di Tolkien e della Terra di Mezzo. Lo stesso problema, infatti, c’era stato qualche anno prima con le nuove traduzioni dei romanzi di Harry Potter, dove molti nomi di personaggi erano stati semplicemente riportati agli originali inglesi e questo era bastato a far infuriare schiere di fan che conoscono i film a memoria.
Mi limito a dire questo.
Non mi capacito che, su 1200 pagine di romanzo, per tanta gente contino soltanto alcuni nomi di alcuni personaggi o alcuni toponimi. E tutto il resto? Centinaia di migliaia di parole, anni di lavoro, di ricerche etimologiche, di consultazioni con esperti, di tira e molla… E poi per tanta gente conta solo la faccenda ramingo/forestale.
È una cosa così importante che vale la pena litigare e insultare le persone?
Se la risposta è sì, alzo le mani.
8 – Chi ha la colpa di questa guerra
Il mio parere è che tutti gli attori in campo si siano mossi come elefanti in una cristalleria. Anzi, come mûmakil (olifanti).
Mi ci metto in mezzo pure io.
Sull’onda dell’emozione per questa epocale novità, nelle prime versioni di questo articolo usai toni decisamente troppo enfatici e parole avventate di cui mi pento. A mia discolpa, non potevo immaginare che il mio articolo sarebbe balzato in cima alla serp di Google e che negli anni sarebbe arrivato a superare le 100mila visualizzazioni totali: nessun altro articolo del mio blog ha mai raggiunto cifre simili, neanche lontanamente. Probabilmente è stato letto o almeno leggiucchiato o sbirciato praticamente da tutti quelli interessati all’argomento.
Quindi, non volendo, nel mio piccolo devo aver contribuito ad esacerbare la discussione. Ma non è comunque il caso che mi sopravvaluti: gli stracci volavano già da mesi.
Ottavio Fatica ha mostrato davvero poco buon senso nell’insultare la vecchia traduzione in un contesto istituzionale come il Salone del Libro di Torino. Usare un’iperbole come «500 errori a pagina» è un’innegabile mancanza di rispetto per un’operazione editoriale che, con tutti i suoi limiti, fu portata avanti in modo avventuroso, quando nessun altro aveva l’interesse o la volontà di farlo e Tolkien era un autore del tutto sconosciuto in Italia. E il mercato editoriale era molto diverso.
D’altra parte, pur non avendo nessuna cognizione di come funzionino i contratti editoriali, 880 euro l’anno per un testo come il Signore degli Anelli sembrano strani. Forse non lo sono, ma un chiarimento da parte di Bompiani su questa faccenda avrebbe aiutato.
Detto questo, se la casa editrice avesse veramente fatto qualcosa di illecito, la questione poteva risolversi in tribunale, anziché nelle librerie. A decidere di far ritirare dal mercato tutte le copie della vecchia traduzione è stata Vittoria Alliata. E tutti quelli che la difendono a spada tratta devono riconoscerle la responsabilità di questa scelta nefasta per la cultura tolkieniana in Italia.
A pagare le spese di questa diatriba sono stati i fan, prima di tutti.
Va anche detto che l’accusa di aver fatto errori nella sua traduzione la Alliata l’aveva ricevuta anche da Quirino Principe: come abbiamo visto il vecchio curatore ha affermato, anche se con un tono più sobrio, di aver dovuto correggere molti errori all’epoca della prima edizione Rusconi. I modi più cortesi non cambiano la sostanza dell’accusa. Ma non ho notizia di querele a Quirino Principe.
In un’intervista su Il Giornale in cui replicava alle accuse, la Alliata s’è poi francamente alienata ogni simpatia da parte del sottoscritto. L’intervistatore è Oronzo Cilli, altro studioso tolkieniano, che ha intitolato l’articolo così:
«Giù le mani da Tolkien. Sì alla poesia no all’ideologia»
La nuova traduzione non era ancora uscita e da destra si diceva che era improntata all’ideologia. E lo ha scritto la persona che, qualche anno dopo, è stata assunta per curare la mostra su Tolkien voluta dal governo Meloni!
In riferimento al raddoppio degli aggettivi, poi, la Alliata ha detto di Ottavio Fatica:
«Costui ha preso per errori delle forme espressive dantesche, come l’endiadi e la dittologia, che evidentemente ignora. […] Venivano usati dal Poeta per esprimere e rafforzare dei concetti […] A chi non le conosce non si può certo affidare la traduzione d’importanti autori»
Insomma, la Alliata rivendica il diritto di infilare questi raddoppi dove non ci sono perché è una roba tipica di Dante Alighieri.
Ma il passaggio più agghiacciante dell’intervista è forse quello in cui si dice che la Bompiani vuole «travestire Il Signore degli Anelli in foggia Lgbt in ossequio al nuovismo».
Ebbene sì, sono arrivati a dire questo.
Che fai, non ce la metti un po’ di Teoria del Gender?
E poi cos’altro? I protocolli dei Savi di Sion?
Dai, mettiamoci pure un complotto di George Soros!
Anni prima, lei stessa si era detta consapevole di come il Signore degli Anelli fosse stato strumentalizzato da «una certa destra culturale italiana». Oggi Alliata di Villafranca è diventata l’eroina della schiera di fan del Signore degli Anelli appartenenti proprio a quell’area politica: quelli che da giovani frequentavano o avrebbero voluto frequentare i «campi hobbit», per capirci. E d’altronde, le sue dichiarazioni e frequentazioni hanno mostrato quanto meno una certa contiguità di vedute con quell’area politica.
Non ci sono state solo le sgangherate recensioni su Amazon e gli articoli su giornali di destra.
Post in cui si affossava la nuova traduzione del Signore degli Anelli sono comparsi in molti blog (per la maggior parte malcelati blog di estrema destra, ma non solo). Ma questa è manovalanza.
Sono arrivati anche i pezzi grossi.
A Gennaio 2019 si è svolto un incontro in una location di grande prestigio, presieduto dall’onorevole Maurizio Gasparri (di cui tutti, credo, conosciamo l’area di provenienza).
All’incontro ha partecipato anche lo Storico Franco Cardini, (medievista ex iscritto al MSI e al movimento neofascista Jeune Europe).
Fra gli interventi intellettuali ce n’è uno che è schizzato in cima alle ricerche su Google, un articolo pubblicato sull’Huffington Post, scritto da Cesare Catà (filosofo, scrittore, traduttore) →questo qui.
Catà si complimenta per la decisione di ritradurre Il Signore degli Anelli, ma poi boccia la nuova traduzione, dicendo di preferire quella vecchia.
E il motivo è il seguente.
La versione di Alliata sarebbe un testo epico-cavalleresco, mentre quella di Fatica «toglie Tolkien dal genere epico per porlo nel genere contemporaneo della Young Adult Fiction».
È una teoria che si è letta spesso in giro e che prosegue il filone Cilli-Alliata del «nuovismo», dell’idea che si sia voluto «ammodernare» un classico stravolgendone la natura.
È una opinione talmente priva di fondamento che c’è da dubitare che chi la esprime abbia davvero letto la nuova traduzione del Signore degli Anelli.
«lì avevano scoperto un sentiero tracciato in epoca remota che ormai pochi osavano intraprendere. S’inerpicava su per la montagna fino a un alto luogo sacro dove soltanto i re erano usi andare. […] E da lì osservarono le terre, perché era mattino; e videro le torri della Città molto più in basso come bianchi pennelli lambiti dalla luce del sole, e tutta la valle dell’Anduin come un giardino, e le Montagne dell’Ombra erano velate da una bruma dorata […] vedevano il fiume svolto siccome un nastro fino a Pelargir e, più in là, una luce sull’orlo del cielo evocava il mare».
Ma magari i romanzi young adult fossero scritti così.
9 – Analisi della nuova traduzione degli Signore degli Anelli
La nuova traduzione del Signore degli Anelli è in generale una traduzione ben fatta, c’è la mano di un professionista e si vede. Non sono emersi errori gravi come nel caso della vecchia traduzione, è evidente il tentativo di dare il senso dello stile di Tolkien al pubblico di lingua italiana, con i suoi picchi dinamici, la variazione dei registri linguistici e l’uso di termini arcaici o desueti o con significati oggi poco conosciuti.
Ottavio Fatica ha molti anni di esperienza nella traduzione della letteratura inglese e si percepisce chiaramente.
Va detto però che questa traduzione alcuni difetti ce li ha.
In particolar modo, Fatica ha fatto un lavoro enorme cercando di restituire in lingua italiana l’uso di Tolkien degli arcaismi, ma trovo che abbia troppo spesso superato il confine tra il voler rendere l’effetto dell’originale e darne una rilettura personale, mettendo termini desueti dove l’originale è molto più immediato. Il risultato è che in alcuni tratti il testo si appesantisce senza motivo.
La lettura della nuova traduzione è generalmente piacevole, ma poi si inciampa in parole francamente stonate, che fanno storcere la bocca e rompono l’incanto della narrazione.
9.1 – Errori nella nuova traduzione del Signore degli Anelli
Erano stati rilevati alcuni problemi nella prima edizione. Ad ogni modo questi difetti sono stati corretti nelle edizioni successive.
Quello che ho fatto nel mio piccolo è andare a controllare come erano stati trattati i passaggi in cui si trovavano gli errori della vecchia traduzione. Mi risultano tutti tradotti correttamente, ma mi permetto di fare le seguenti notazioni.
Si è scelto di continuare a numerare i libri con i numeri ordinali e i capitoli con numeri romani, invece dei meno altisonanti numeri arabi. Che però sono quelli usati da Tolkien. Io non trovo una giustificazione a questa modifica dell’originale.
Il termine «Shieldmaiden».
Purtroppo anche nella nuova traduzione non abbiamo una totale uniformità: nella prima occorrenza (Libro Cinque Cap. 2) questa parola è stata tradotta come guerriera. Nelle altre tre occorrenze (Libro Sei Cap. 5) come fanciulla guerriera. Secondo me non ha senso usare fanciulla-guerriera, perché una shield-maiden non sembra avere una particolare connotazione anagrafica, né deve essere necessariamente una vergine. Éowyn parla di se stessa semplicemente come di una shieldmaiden, senza altri aggettivi. A me sembrerebbe più corretto attenersi sempre e solo a un generico «guerriera».
– Nel Libro Sei Cap. 3, «shone now as if verily it was wrought of living fire» (riferito all’Anello) è stato tradotto da Fatica come «Ora brillava come se davvero fosse contesto di fuoco vivo».
Fatica fa uso spesso della parola «contesto», termine indubbiamente colto che è aggettivo derivato dal verbo contessere e che significa intrecciato, tessuto insieme e, in senso figurato, composto con oppure messo insieme a.
Come abbiamo già detto, «wrought» è un termine intraducibile in italiano, perché significa al tempo stesso ornato, ma anche fabbricato (nel senso di un prodotto artigianale) e, nel caso di oggetti di metallo, forgiato.
Tolkien ha usato questo termine in modo ambivalente, sfruttando almeno due dei suoi significati: ornato e fabbricato-forgiato. È una sfumatura importantissima, perché siamo nel momento in cui l’Anello torna al luogo in cui è stato creato per essere distrutto. Qui si conclude la storia dell’Anello, che compie un percorso circolare (e non è da escludere che uno come Tolkien trovasse divertente il fatto che la storia di un anello avesse un andamento circolare). Il riferimento inserito dall’autore alla fabbricazione-forgiatura mi pare essenziale.
La frase originale è impossibile da rendere in modo letterale, ma l’utilizzo di «contesto» secondo me inserisce un riferimento alla tessitura laddove era necessario uno alla forgiatura.
9.2 – I Registri linguistici
La nuova traduzione tenta di riproporre l’effetto della variazione dei registri linguistici usata da Tolkien. È un’operazione più complessa di quanto possa sembrare, perché, come abbiamo accennato, nel testo originale si fa ampio utilizzo di forme linguistiche provenienti dall’antico anglosassone o dal norreno, in un complesso intreccio tra il mondo primario e quello secondario. Davvero difficile rendere tutto questo nella lingua italiana, tanto diversa dall’inglese per forma e storia evolutiva.
Ottavio Fatica ci prova, facendo largo uso di termini desueti e ricercati, che spesso trovano agganci nella storia della letteratura Italiana. I capitoli ambientati nella Contea hanno un tono leggero e moderno mentre, man mano che ce ne allontaniamo assieme agli hobbit, quando il mondo si fa sempre più strano, fantastico, eroico e «antico», il linguaggio si arricchisce di arcaismi, termini aulici e aggettivi che precedono i nomi.
Un termine che mi ha colpito fin dalla prima lettura della nuova traduzione del Signore degli Anelli è stato «cotica», per indicare lo strato di erba con le relative radici e il terriccio a cui si aggrappa. Questa parola può far storcere il naso, perché suona come un arido tecnicismo. Eppure la si ritrova più volte nella Trilogia dell’Altipiano di Mario Rigoni Stern, in cui il grande scrittore asiaghese parla di lunghi viaggi a piedi tra le montagne, delle devastazioni portate della guerra, di amicizia, della bellezza della vita semplice e dell’importanza di difendere la natura. Vi fanno venire in mente qualcosa, questi temi?
Il nome di Passolungo è stato usato da Fatica per tradurre Strider (al posto del vecchio Grampasso) perché è un riferimento alla traduzione italiana di un racconto di Lev Tolstòj, dedicato a un cavallo di nome Cholstomér, che nella versione firmata da Corrado Alvaro è «Passolungo: storia di un cavallo». Siccome poi Frodo, verso la fine del romanzo, decide di chiamare il suo cavallino Passolungo, il riferimento al cavallo assume un doppio rimando. Infine, Fatica ha raccontato di avere poi scoperto che, nella versione inglese del racconto di Tolstoj, «Cholstomér» è stato tradotto Strider.
Se nella nuova traduzione ci sono riferimenti interessanti e collegamenti più o meno diretti con autori italiani e non, l’uso di termini aulici e ricercati a volte suona eccessivo. Si è certamente cercato di sopperire all’intraducibilità di alcuni termini e giochi linguistici di Tolkien inserendo arcaismi e forme poetiche dove l’originale risulta più piano e scorrevole; ma spesso il risultato è di far incagliare il testo in parole che suonano messe a forza e che spingono improvvisamente il lettore fuori dall’immersione narrativa.
La mia prima lettura della nuova traduzione del Signore degli Anelli mi aveva entusiasmato per la ricchezza linguistica e la variazione del tono. Ma alle successive riletture ho cominciato a notare una serie di dettagli che suonano come veri e propri inciampi.
L’impressione generale è che a volte il nuovo traduttore si sia fatto prendere la mano in una ricerca manichea di sofisticatezze che non sempre sembrano avere lo stesso effetto dell’originale in lingua inglese.
A me pare che nella scrittura di Tolkien tutto abbia sempre una motivazione, un collegamento con la storia e i suoi personaggi oppure un ammiccamento al lettore. Non credo che il professore avrebbe mai inserito una parola arcaica solo perché dava il senso di una roba antica. Altrimenti si rischia di incorrere nello stesso problema della traduzione Alliata-Principe, di usare un «linguaggio per luoghi comuni di provenienza aulica», cioè il «parlar giusto» che diceva Furio Jesi, che sembra nobilitante ma che non vuol dire niente.
Col passare del tempo ho iniziato a sospettare che Ottavio Fatica abbia avuto qualche problema a entrare davvero in sintonia con Tolkien. E questo si riflette in parte sulla traduzione.
9.3 – Un Traduttore non tolkieniano
Fatica non aveva letto il Signore degli Anelli, prima di iniziare il suo lavoro, è un fatto noto.
Non so quanto questo possa essere collegato ai problemi che riscontro nella sua traduzione. E nessuno può essere sicuro che un traduttore fan di Tolkien sarebbe riuscito a fare un lavoro qualitativamente migliore. Però trovo un collegamento tra un certo modo di affrontare il testo e certe cose dette in pubblico dal nuovo traduttore.
Tra il 30 novembre e il 1 dicembre 2020 si è svolto un convegno presso l’Università di Trento dal titolo «Fallire sempre meglio: tradurre Tolkien, Tolkien traduttore». Al convegno hanno parlato diversi traduttori di Tolkien (italiani e non), tra cui anche Ottavio Fatica. Gli atti del convegno sono poi stati pubblicati nel numero dei Quaderni di Arda che abbiamo già citato, che si apre proprio con l’intervento di Fatica, che così ha potuto essere letto da tante persone che non erano a Trento quel giorno, me compreso.
Il discorso di Ottavio Fatica mi ha lasciato perplesso.
Mi aspettavo una relazione un po’ più tecnica sul suo lungo lavoro; le spiegazioni tecniche non sono mancate, ma sono state solo una parte delle 18 pagine di intervento. Molte pagine sono dedicate alle critiche a Tolkien.
Prima di procedere una nota: l’incontro di Trento è del 2020, ma nel frattempo Ottavio Fatica non ha cambiato idea: in un incontro del 2025 di cui è stata pubblicata una registrazione video su YouTube ha detto le stesse cose.
Dicevamo.
Racconta di aver scoperto i versi nascosti nella prosa di Tolkien e che li ha tradotti usando anche lui versi nascosti. Ma non ci dice dove sono. Ne aveva già parlato in altri interventi, ma stavolta speravo che entrasse più nel dettaglio, invece no. Con versi nascosti intende l’uso della scrittura in versi all’interno di un’opera in prosa ma senza incolonnarli e senza usare rime, che li renderebbero più facilmente identificabili. I «versi nascosti» sono difficilissimi da scovare, è possibile trovarli leggendo ad alta voce, ma possono sfuggire lo stesso.
Scrive Fatica:
«Partirò da una breve carrellata sulle critiche più degne di rispetto, ormai tacitamente cantonate per pigrizia, ignoranza, convenienza o cecità dai più. Ma sempre valide».
Credo che in questo contesto valga la pena darci un’occhiata, a queste critiche «sempre valide».
9.4 – Osservazioni sulle critiche di Ottavio Fatica
Fa i complimenti a Tolkien, dice che ha «fantasia, visionarietà, ritmo narrativo incalzante, senso animistico della natura, solida tenuta nei passi di crescendo epico e molto altro ancora». Ma è tutto qui, meno di due righe per dirci cose che capisce anche chi legge Tolkien per la prima volta.
Il dubbio nasce spontaneo: per Fatica questo «tanto altro ancora» esiste o è solo una formula di cortesia?
Il rifiuto degli intellettuali italiani
Inizia giustificando la stroncatura fatta da Vittorini che sconsigliò a Mondadori la pubblicazione del Signore degli Anelli, perché, dice «la bocciatura italiana rispondeva al gusto dell’epoca. Qui da noi dovevano ancora smaltire, dopo averlo imposto, il realismo americano di una generazione precedente».
A me questo discorso non è chiaro, sono sincero. Non metto in dubbio la conoscenza della storia della letteratura e dell’editoria italiana da parte di Fatica, ci mancherebbe. Ma mi sembra dare per scontati dei concetti che forse non lo sono.
In che senso bisognava «smaltire il realismo americano»? Nel senso che esiste una sorta di percorso evoluzionistico, per cui si doveva digerire una corrente letteraria precedente, per apprezzare qualcosa di completamente diverso? Le due cose non potevano coesistere?
Non c’erano altri fattori in gioco? Non c’era una tendenza degli intellettuali italiani a voler imporre un certo tipo di visione del mondo e della cultura, mettendo in secondo piano la qualità delle opere? Sappiamo che Vittorini scartò anche Il Gattopardo e Il Dottor Zivago, che valse il premio nobel a Pasternak.
Non ha avuto un peso importante il fatto che gli intellettuali italiani fossero legati a una visione ortodossa del marxismo, nella stessa epoca in cui i filosofi della Scuola di Francoforte proponevano con grande successo un marxismo anti-sovietico, rinnovato e molto più aperto? Come abbiamo visto, solo L’Uomo a Una Dimensione di Marcuse vendette 250mila copie in Italia.
Sbaglierò, ma sono dell’idea che era la classe dirigente italiana a non essere pronta ad apprezzare Il Signore degli Anelli. Mentre non ci sono motivi per pensare che i ragazzi italiani non lo fossero.
Sono convinto che la contrarietà al fantastico della classe dirigente italiana abbia fortemente contribuito a creare una barriera culturale, con conseguenze sull’editoria italiana che ancora adesso ci portiamo dietro. I lettori italiani di oggi sono affamati di fantastico e il genere è un traino potente per tutto il mercato editoriale; al tempo stesso però c’è una radicata diffidenza verso gli scrittori italiani di fantastico, come se fossero intrinsecamente inadatti al genere (che non è ovviamente vero).
L’origine di questo antico male merita una certa attenzione, credo.
Gli Anacronismi
Fatica poi ci racconta dei tanti anacronismi, delle incongruenze linguistiche, dei latinismi, grecismi e francesismi che non dovrebbero esserci in un testo ambientato nella Terra di Mezzo; come pony, night-walkers, driade, babele, Geronzio, Sancho o falange; all’elenco io aggiungerei «naftalina» (che è nata negli anni ’20 dell’800). È un argomento molto interessante.
Secondo lui, si tratta di veri e propri errori da parte di Tolkien, che usa degli escamotage per giustificarli, come la traduzione dall’ovestron.
Nella finzione narrativa, Il Signore degli Anelli è la traduzione in inglese del Libro Rosso della Marca Occidentale, scritto in lingua ovestron.
A volte, Tolkien usa parole e nomi moderni ma sostiene che vengano dalle antiche lingue della Terra di Mezzo, oppure che abbiano origini diverse da quelle che uno si aspetterebbe: come il cognome Cotton che non verrebbe da cotone, oppure il soprannome Sharkey che non verrebbe da squalo. Dice Fatica:
«Passa dalla filologia alla narrativa, o viceversa, quando e come più gli aggrada o gli conviene? Prende in giro? Perché no? Ma allora perché tanto rigore in altri casi? O è seriosità? Non può metterla in burletta perché alle strette, per uscire da una trappola. Troppo comodo. È sleale nei confronti del lettore».
Come lettore non ho mai pensato che Tolkien fosse «sleale». Penso che Il Signore degli Anelli è un gioco e che, come tutti i giochi, può essere a tratti serissimo, a tratti scherzoso. A volte usa dei normalissimi stratagemmi narrativi: perché tutti gli anacronismi non potrebbero essere imputati al finto traduttore dall’ovestron all’inglese? Cosa c’è di «sleale»?
Sicuramente io non sono attenndibile perché faccio «parte di una setta», ma a me pare evidente che certi anacronismi sono dei giochi voluti, almeno alcuni di quelli nella Contea (vedi il fuoco d’artificio a forma di drago «che passò come un treno espresso» o, appunto, la naftalina). Tolkien vuole rendere l’ambientazione ambigua; la società degli hobbit è ricalcata sul mondo agricolo inglese di fine ‘800-primi del ‘900 (anche se privato di tutta la tecnologia). Questa ambiguità è funzionale a quello che sembra essere una sorta di viaggio nel passato compiuto da Frodo e compagni quando lasciano Bree insieme ad Aragorn. È un tema centrale. Se non si capisce questa cosa del viaggio nel tempo, secondo me, non si capisce un aspetto cruciale del romanzo.
La preveggenza
A proposito del fatto che Gandalf prevede che Gollum avrà un ruolo importante nella storia, dice: «Una soluzione dettata da esigenze narrative, frutto magari dei calcoli a ritroso dell’autore, assurge a destino».
Lo ha detto per spiegarci quanto, secondo lui, fosse ingenua la lettura di Wystan Hugh Auden, il poeta anglo-americano che fu uno dei pochi intellettuali (ma non l’unico) ad accogliere positivamente Il Signore degli Anelli all’epoca della sua prima pubblicazione.
Ma non è come protestare davanti a un gioco di prestigio dicendo che «è solo un trucco»?
Stupire i lettori, giocare col loro desiderio di meraviglioso sfruttando tutti i mezzi a disposizione non fa parte del ruolo di un bravo narratore?
Senza contare che la preveggenza ha un ruolo importantissimo in tutto il romanzo. Non è una prerogativa del solo Gandalf, ma anche di Aragorn e di Elrond, per non parlare di quando Frodo e Sam guardano nello specchio di Galadriel. Tolkien sfrutta questo artificio per introdurre il tema a lui caro della provvidenza e per dare più spessore ai personaggi e al modo in cui si evolvono.
Fare candidamente a pezzi gli orchi
Fatica ha esposto la critica (certo non nuova) al fatto che nel Signore degli Anelli gli esseri malvagi sono sterminati senza pietà e Gimli e Legolas fanno «a gara a chi ammazzerà più orchi». La superficialità di questa osservazione mi pare lampante: nel Signore degli Anelli il tema dell’uccisione dei nemici è trattato in modo tutt’altro che banale e carico di significati per il nostro presente.
Nel mondo di Tolkien alcune creature, quando compiono il male, hanno diritto alla redenzione, mentre altre no. Oppure ce l’hanno ma con molti però. La questione è complessa e pare che neanche Tolkien sia mai stato in grado di risolverla.
Incredibilmente, proprio nei giorni in cui stavo scrivendo queste righe, Paolo Nardi (youtuber profondo conoscitore dell’opera di Tolkien e membro dell’AIST) ha pubblicato un video dal titolo «Gli Orchi possono essere redenti?» in cui approfondisce la questione come io non sarei mai stato in grado di fare. Ne consiglio la visione.
Ad ogni modo, il punto è che per il cristiano Tolkien gli uomini hanno il libero arbitrio, dunque hanno sempre la possibilità di scegliere il bene e quindi di essere perdonate. Ma per le creature nate nel male la faccenda è diversa. Quanto sono libere di scegliere? Potrebbero mai pentirsi? Si può parlare di libero arbitrio, nel loro caso?
Coloro che scelgono la via del male, come i landumbriani, gli haradrim, oppure Saruman, Gollum o Vermilinguo non vengono mai assassinati, sono sempre oggetto di misericordia. Non importa se continuano a sbagliare. A Saruman viene offerta per varie volte la possibilità di tornare sulla retta via e mai viene giustiziato perché si rifiuta.
Ma gli orchi possonno scegliere di fare del bene? Tutto fa pensare di no.
Chiedersi se sia giusto sterminare gli orchi senza pietà è un po’ come chiedersi se in un film di zombie è giusto che i protagonisti facciano a pezzi tutti i morti viventi che incontrano.
Nel Signore degli Anelli traspare una riflessione su questi temi. Cosa che, per esempio, non ho trovato nell’amico di Tolkien C.S. Lewis, dove al contrario gli antagonisti sono sempre aggrediti e massacrati senza pietà e senza alcun tipo di riflessione etica (sia nelle Cronache di Narnia, sia nella Trilogia Cosmica).
La domanda è: se penso di essere nel giusto, ho diritto di sterminare i miei nemici?
La risposta nel Signore degli Anelli sembra essere: dipende.
Se i nemici sono esseri umani la risposta è no, inequivocabile. Che non è una banalità, visto che nel mondo continuano a perpetrarsi genocidi.
Se non sono esseri umani, la faccenda è più complessa e si porta dietro un carico di domande a cui non sappiamo rispondere. Si tratta di orchi capaci solo di odiare, distruggere e uccidere? Zanzare portatrici di malaria? Ratti che infestano i centri storici delle città che noi abbiamo reso troppo sporche e inquinate? Animali selvatici che ci disturbano e spaventano? Dove sta il confine tra male e bene, tra giusto e sbagliato? Tolkien non sembra aver trovato una soluzione e ha lasciato la questione aperta.
Che il traduttore del Signore degli Anelli si faccia una risatina su un tema complesso come questo non è segno di una certa superficialità?
Credenza primaria e credenza secondaria
Ottavio Fatica ha poi esposto la teoria tolkieniana della differenza tra credenza primaria (legata al mondo reale) e credenza secondaria (legata al «mondo secondario», cioè quello inventato), secondo cui c’è sempre il rischio di cedere alle lusinghe della fantasia e applicare la credenza primaria al mondo secondario; cioè, in pratica, credere che il mondo di fantasia sia reale o quasi e non volerne più uscire (che poi è uno dei temi centrali de La Storia Infinita di Michael Ende; ma non divaghiamo).
«La fantasia muore, diventa illusione morbosa», dice Fatica. «Ed ecco che il lettore vagheggia Frodo impelagato in altri frangenti e reclama nuove avventure».
Poi, a proposito di quanto i fan elogiano Tolkien, dice: «Non occorre sostenerlo a ogni piè sospinto, non sta cadendo […] A vederlo così sorretto sembra di avere a che fare con un catafalco. La non unanimità del suffragio è l’ossigeno dell’arte. Mai pensare di un libro: qui sta la Verità».
Se vi state chiedendo perché l’autore della nuova traduzione del Signore degli Anelli ha ritenuto di dover dire queste cose a un convegno dedicato a Tolkien e la traduzione, siamo sulla stessa barca. Ma una cosa è chiara: Ottavio Fatica si riferisce ai fan. Dirò di più: ho il sospetto che non solo non apprezzi il fandom, ma che non lo abbia capito.
Non credo ci sia molto da aggiungere, se non che ancora oggi, dopo tanti decenni, dobbiamo continuare a constatare come per molti intellettuali sia impossibile comprendere il semplice gioco di essere fan, di continuare anche da adulti a essere un po’ ragazzini, a rileggere, riguardare, comprare cianfrusaglie, attaccare adesivi, collezionare, discutere, perfino mascherarsi. Non solo questo: per certe persone è impossibile capire il gioco di innamorarsi perdutamente della narrativa di evasione. E che Tolkien, nonostante fosse uomo di immensa cultura e grande studioso, giocava a questo stesso gioco.
Non posso ovviamente parlare per tutti i fan, ma francamente mi pare un po’ ridicolo pensare che per un ammiratore il Signore degli Anelli possa contenere la «Verità». La definizione di «setta» non è solo offensiva: è il segno dell’incapacità di capire un fenomeno culturale di portata globale.
Che il traduttore del Signore degli Anelli non sia un fan non è un problema. Ma che non abbia capito queste cose è un po’ triste, questo sì.
Difendere Fatica a tutti i costi?
Non frequentando i social, non posso riportare cosa s’è detto delle parole di Ottavio Fatica nei forum e nei gruppi, sempre che siano state commentate.
Wu Ming 4 ha detto la sua in un articolo per il sito dell’AIST, che poi è stato ripubblicato da Eterea Edizioni in Il Fabbro di Oxford – Scritti e interventi su Tolkien.
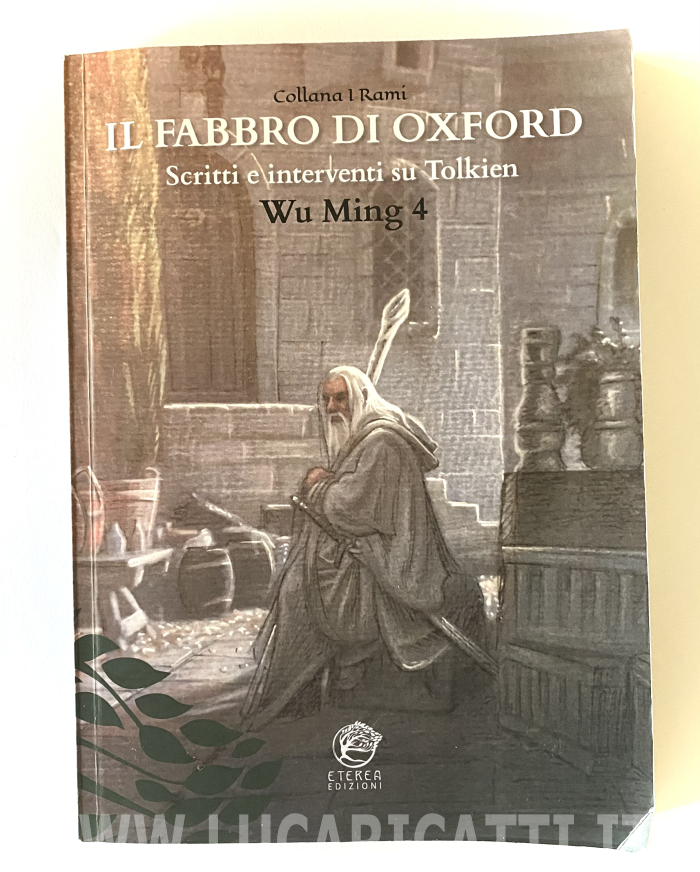
Sono un ammiratore di Wu Ming 4, sia come studioso di Tolkien che come romanziere (mi è piaciuto molto il suo La Vera Storia della Banda Hood). Ma in questo caso non posso proprio essere d’accordo.
In buona sostanza Wu Ming 4 difende Ottavio Fatica, dice che: «di questo sguardo esterno, disincantato, professionale, noi tolkieniani abbiamo bisogno per arieggiare il nostro ambiente, se non vogliamo che diventi autoreferenziale, asfissiante, asfittico».
Io tutta quest’aria fresca nel discorso di Fatica non ce l’ho sentita. Anzi, ho trovato la riproposizione di critiche vecchie di decenni e spesso superate. Ad ogni modo, credo che lo «sguardo disincantato» si dovrebbe applicare anche alla nuova traduzione del signore degli Anelli e al suo traduttore. La nuova traduzione del Signore degli Anelli è bella ed è un importante passo avanti, però qualche difetto ce l’ha. E questi difetti sono anche legati a certi limiti tipici di molti intellettuali che si scontrano con Tolkien e con la narrativa fantastica in generale.
9.5 – Le nuove traduzioni dei nomi
La faccenda dei nuovi nomi del Signore degli Anelli è stata talmente discussa, sia dagli specialisti che, diciamo, a un livello «più basso» («il nuovo traduttore ha ha fumato troppa erba pipa», oddio che risate) che è difficile parlarne senza provare un senso di stanchezza e anche di noia.
Sono stati ritradotti molti dei nomi, quasi tutti in effetti. In generale, tutte le nuove traduzioni hanno dietro un ragionamento e un approfondimento. Al nuovo traduttore va senza dubbio riconosciuto il merito di aver sempre cercato di trovare nomi che riproponessero il senso di quelli originali voluti dall’autore.
È stata la scelta corretta? Col passare del tempo mi sono convinto che lo è stata fino a un certo punto, ma ne parliamo sotto.
Prima facciamo alcuni esempi, per far capire il modo in cui si è lavorato.
– I farthings nella vecchia traduzione erano Decumani. Come in molti altri casi, Tolkien ha usato una parola che ha un significato moderno e uno più antico, giocando con questa ambiguità. In old english feorðing significava «un quarto» e, secoli dopo, la parola farthing è andata a indicare una moneta (oggi non più in uso) del valore di un quarto di penny. Il termine è rimasto per indicare qualcosa di scarso valore. Dunque, in lingua originale il fatto che gli hobbit chiamino le quattro parti in cui è suddivisa la Contea «farthings» ha una effetto un po’ comico.
«Decumano» non ha nulla di comico, oltre al fatto che richiama l’organizzazione militare e urbanistica dei romani, piuttosto fuori luogo nella Contea. Resta però che il termine originale è intraducibile. Fatica ha trovato «Quartiero», che è una forma antica per quartiere e che, in effetti, anticamente indicava la quarta parte di una città. Ha una effetto vagamente buffo, anche se non come l’originale per i madrelingua inglesi.
– La locanda Prancing Pony nella vecchia traduzione era Puledro impennato. Ovviamente un pony non è un puledro e la differenza non è da poco, perché si tratta di una locanda frequentata sia da uomini che da hobbit e questi ultimi cavalcano i pony; dunque il nome suona come un invito a frequentarla per la «gente piccola»: fa pensare a un luogo sicuro e accogliente per quattro hobbit stanchi, impauriti e inseguiti dal nemico sotto un temporale.
Il termine «prancing» è usato in araldica. In lingua italiana la tradizione araldica richiede che per il cavallo si usi «inalberato».
Molti hanno polemizzato sostenendo che «inalberato fa pensare a arrabbiato» e che sarebbe stato più bello «rampante». Ma per l’araldica tradizionale italiana sarebbe un errore inaccettabile, perché rampante si può usare solo per i leoni. L’unico termine accettabile è inalberato e quindi Fatica ha tradotto «Cavallino Inalberato».
Suona bene? Secondo me no.
Si poteva trovare una traduzione migliore? Secondo me no.
Il proprietario del Prancing Pony è Barliman Butterbur, che nella vecchia traduzione era Omorzo Cactaceo. Butterbur in italiano è il farfaraccio e perché la traduzione Alliata-Principe lo abbia trasformato in un aggettivo legato ai cactus è un mistero. «Omorzo» invece è una buona idea perché è una traduzione di barley-man, cioè «uomo dell’orzo», dunque Omorzo. E infatti Fatica lo ha tenuto, ma correggendo il cognome in «Farfaraccio».
Samwise Gamgee nella vecchia traduzione era «Samvise», che era una semplice italianizzazione basata sull’assonanza. Ma sam-wise sta per «mezzo saggio», ovvero sciocco o sempliciotto. Fatica ha recuperato un vecchio nome italiano caduto in disuso da secoli, «Simplicio», trasformando la i in a così da poter mantenere la stessa abbreviazione Sam del testo originale.
Mi piace Samplicio Gamgee? No.
Si poteva fare una traduzione migliore? Ne dubito.
Sulla questione di Ranger rimando all’articolo di approfondimento scritto da Wu Ming 4, contenuto in Il Fabbro di Oxford ma leggibile gratuitamente sul sito dell’AIST: Aragorn il Forestale, uno studio filologico.
Ad ogni modo, questo è in assoluto quello che ha più aizzato i detrattori.
Il termine inglese «ranger» oltre a significare «guardaboschi», «guardiacaccia» e simili, significa altre cose: vagabondo (in senso dispregiativo) e un particolare corpo d’armata delle truppe americane (i cui eredi sono i moderni Texas Ranger).
Il termine usato da Tolkien è un insieme di tutte queste cose.
La vecchia traduzione si basava anche questa volta soprattutto sull’assonanza (ranger – ramingo) ma, dal punto di vista del significato, riduce la complessità dell’originale a un solo significato, per di più edulcorandolo: ramingo ha un accento poetico, è nobilitante; è la solita tendenza della vecchia traduzione a modificare il testo verso un tono lirico-cavalleresco.
L’inadeguatezza di ramingo diventa evidente quando deve essere applicata a Faramir e alla sua truppa, perché raminghi non ha alcuna accezione militare ed è indubbiamente fuori luogo.
Con «Forestale», Fatica invece ha condensato insieme i molteplici significati del termine originale.
L’obiezione più comune è «mi fa pensare ai guardaboschi!» Esatto! È esattamente quello che hanno pensato i lettori di lingua inglese quando hanno letto per la prima volta The Lord of the Rings.
Con la questione dei nomi credo che possiamo fermarci qui, perché abbiamo capito il metodo con cui si è proceduto: scoprire il significato che Tolkien aveva pensato per i nomi della sua storia e cercare di trovare qualcosa che desse lo stesso effetto in lingua italiana.
Ora (anche a seguito di alcuni scambi di commenti con alcuni lettori di questo articolo), sono arrivato alla conclusione che ritradurre i nomi sia stato un errore. Non nel senso che si dovessero lasciare quelli Alliata-Principe, che erano evidentemente quasi tutti inadeguati, ma che si dovessero ripristinare i nomi originali in lingua inglese.
La logica alla base dell’idea che i nomi vanno tradotti è la seguente: se, nella finzione narrativa, Il Signore degli Anelli è la traduzione in inglese del Libro Rosso scritto da Bilbo e Frodo, allora una traduzione italiana deve tradurre in italiano tutti i termini inglesi, compresi i nomi. In effetti ha senso.
Il problema di questo approccio è che non tiene conto dei fattori extra-letterari, di ciò che sta intorno all’opera di Tolkien.
Non siamo più nell’Italia dei primi anni ’70. Oggi le persone prendono lo smartphone per andare su un social network a fare scrolling dove leggono della nuova shitstorm che ha colpito la famosa influencer, ma vengono interrotti dallo spot creato dal team pubblicitario della corporation che punta tutto sulla customer retention… eccetera eccetera. La lingua inglese fa parte della nostra quotidianità.
Anche il lettore che apre per la prima volta Il Signore degli Anelli sa qualcosina sul conto di Tolkien e ha già sentito nominare gli hobbit, Sauron e l’Anello del potere. Probabilmente ha già visto i film. Chiunque quando legge della Contea si rende conto che fa pensare alla campagna inglese: in un’ambientazione simile non suona meglio «Samwise» che «Samplicio»?
E d’altra parte, che senso ha che certi hobbit abbiano nomi italofoni e cognomi anglofoni?
Fatica ha detto di essersi pentito, che avrebbe dovuto tradurre tutti i nomi hobbit. Così saremmo tornati al «Frodo Sacconi» a cui aveva pensato originariamente Vittoria Alliata? Al solo pensiero mi sento mancare.
A mio modesto parere resta necessario tradurre alcuni toponimi come Contea, Vecchia Foresta, Poggitumuli, Pian della Battaglia, eccetera; e i nomi-soprannomi, che devono avere un un’intellegibilità immediata, come Passolungo, Ombromanto, Vermilinguo o Barbalbero. Ma continuare a ibridare o pretendere di tradurre tutto secondo me oggi è anacronistico e inutile.
Analisi di alcuni capitoli
Al di là delle impressioni avute durante la lettura (e riletture) della nuova traduzione del Signore degli Anelli di Ottavio Fatica, ho pensato che fosse utile un’analisi un po’ più approfondita, «compulsando» alcuni capitoli. È una cosa che ho voluto fare per me, prima di tutto, ma che penso possa risultare interessante anche per altri.
Ho scelto i primi capitoli dei libri dispari, ovvero quelli che aprono i tre volumi della trilogia.
Libro Uno, Capitolo 1: «Una festa attesa a lungo»
L’impressione generale che ho di questo capitolo è che risulta scorrevole, piano, leggero e giocoso e, per quello che sono in grado di capire, molto simile all’originale, laddove la vecchia traduzione suonava più paludata, inutilmente seriosa. Tuttavia, ci sono alcuni «inciampi» per me inspiegabili.
Il primo lo trovo già alla seconda pagina, ed è la traduzione di the Gaffer, che nella versione Alliata-Principe era stato reso con la parola inesistente in lingua italiana «Gaffiere», per il solito modo di procedere che prediligeva l’assonanza al significato.
Stando a vari dizionari online, gaffer è una parola «informal», che ha diversi significati, tra cui «persona responsabile di altri lavoratori», quindi capo, caposquadra e simili, ma anche uomo anziano; e poi c’è il significato per il quale questa parola si incontra spessissimo nei titoli di coda dei film americani, cioè capo elettricista.
Evidentemente, riferito al padre di Sam, Hamfast Gamgee, che è un giardiniere, il soprannome Gaffer sta a significare che è una persona anziana che ha trascorso la vita a fare un lavoro di tipo operaio, ma molto rispettata nella comunità perché considerata di grande esperienza, capace di spiegare agli altri le cose. Infatti sappiamo che ha insegnato il mestiere al figlio. La prima volta che lo incontriamo, sta spiegando cose ad altri hobbit «proletari» come lui (sulla storia della famiglia Baggins).
Ottavio Fatica ha scelto di tradurre the Gaffer con il Veglio.
Ora «veglio» è evidentemente un termine tutt’altro che «informal», ma «antico e poetico», stando al Treccani. Significa vecchio e degno di nota, ma non ha nulla a che fare coi membri della classe operaia. Anzi, in bocca a loro suona decisamente improbabile.
Poche pagine più avanti, troviamo la traduzione di Dale (la città abitata da uomini ai piedi della Montagna Solitaria), che Ottavio Fatica ha reso con «Vallea».
A quanto mi risulta, la parola dale è utilizzata ancora oggi nell’Inghilterra settentrionale per indicare una zona ricca di valli o anche semplicemente una valle. Questa parola viene dall’antico inglese, ma sembra essersi attestata per influenza del norreno dalr (abbiamo visto che per i nomi di quell’area della Terra di Mezzo, Tolkien si è ispirato al norreno).
Scegliendo di tradurre Dale con Vallea, Fatica ha tradotto con un termine poetico e arcaico. È vero che nell’originale c’è una parola usata solo in una ristretta area geografica e che quindi suona curioso per la maggior parte dei lettori anglofoni; ma è un termine così aulico?
Durante la festa di compleanno di Bilbo, a un certo punto una coppia di hobbit, presa dall’euforia sale su un tavolo, e Tolkien dice che iniziano a ballare una «pretty dance, but rather vigorous», letteralmente, una una danza bella ma piuttosto vigorosa. Fatica traduce con «un gran bel ballo ma gagliardo assai».
Quando Bilbo si infila l’Anello e sparisce davanti a tutti, solo il vecchio Rory Brandibuck capisce che «quel vecchio pazzo» di Baggins se n’è andato di nuovo, per poi dire a se stesso «But why worry?», letteralmente «Ma perché preoccuparsi?»
Fatica traduce con «A che pro preoccuparsi?»
Poi Bilbo torna a casa per prepararsi alla partenza e ci trova Gandalf, che ammette di aver emesso un lampo per far credere di essere responsabile dell’improvviso «vanishment» di Bilbo, che Fatica traduce con «sparigione». E qui forse ha fatto bene, perché mi risulta che vanishment sia una forma obsoleta. Immagino che Tolkien abbia messo in bocca a Gandalf parole come questa per dare l’idea di un essere antico che, pur cercando di parlare in modo semplice quando è in presenza degli hobbit, ogni tanto si fa scappare qualche termine in disuso. Tolkien usa le parole arcaiche in modo funzionale al racconto.
Libro 3, Capitolo 1: «La Dipartita di Boromir»
Il capitolo si apre con la frase «Aragorn sped on up the hill», letteralmente «accelerava» sulla collina. Fatica ha tradotto «Aragorn s’inerpicava in fretta su per la collina». A me pare abbastanza lontana dall’originale per costruzione, ritmo e soprattutto senso. «Inerpicarsi» è «arrampicarsi faticando», ma nell’originale Aragorn non sembra avere alcuna difficoltà: non solo va veloce sulla salita di Amon Hen, ma addirittura «accelera».
Subito dopo, arrivato in cima al colle, Aragorn si siede sull’antico seggio in grado di dare una vista portentosa e leggiamo: «Then sitting in the high seat he looked out», letteralmente «sedendosi sull’alto seggio guardò/osservò/controllò». Nella nuova traduzione leggiamo: «Poi, sull’alto seggio assiso, si guardò intorno». Perché la posticipazione del verbo? E perché l’aulico «assiso invece del semplice «seduto, dove l’originale porta un normalissimo «sitting»?
Quando Boromir esala l’ultimo respiro, Aragorn commenta amareggiato: «Thus passes the heir of Denethor», letteralmente: Così passa l’erede di Denethor, che Fatica traduce: «Così viene a mancar l’erede di Denethor. Non mi piace molto il troncamento del verbo «mancare», la frase originale suona elegante e semplice al tempo stesso, mentre così suona un po’ ridicola, fa l’effetto «armata Brancaleone» (formula usata dallo stesso Fatica). Ma non è questo il problema. Qui il traduttore sembra non essersi accorto di una finezza del professore.
Alla morte di Denethor (Libro Cinque, Cap. 7), Gandalf usa la stessa formula per la morte del padre di Boromir: «So passes Denethor son of Ecthelion», ma lì Fatica non ha usato lo stesso verbo e ha tradotto: «Così è perito Denethor figlio di Ecthelion».
Sono due momenti di svolta della trama, forse un pizzico di pignoleria in più ci sarebbe voluta. È un parallelismo molto bello ed è un peccato che si perda.
Quando pongono Boromir sulla barca con le armi affidando il suo corpo al fiume Anduin, Tolkien dice che il defunto «floated by them», letteralmente «galleggiò accanto a loro». Fatica traduce: «Trascorse accanto a loro». «Trascorrere» è una forma letteraria per dire correre attraverso o anche solo passare. Ottavio Fatica usa spesso questo verbo, anche se nella maggior parte dei casi nel senso più comune di passare il tempo
In questo brano lo scrive per tradurre to float, altre volte per tradurre to pass o to pass over, oppure to flow. (fluire, scorrere). Mette questa forma letteraria per tradurre verbi che a me sembrano piuttosto comuni in inglese, per altro ogni volta diversi.
Il capitolo si chiude con la frase «Trascorrevano, ombre grigie su landa petrosa» per tradurre «They passed away, grey shadows in a stony land», dove al posto di un semplice pietroso Fatica ha optato per il letterario petroso.
Poco prima, Aragorn spiega a Legolas e Gimli che Frodo è scappato, seguito da Sam, per proseguire la sua missione senza di loro, e Gimli commenta: «That was a strange deed!» e Aragorn risponde: «And a brave deed». Letteralmente: «È stato uno gesto strano!», «E un gesto coraggioso».
Fatica ha tradotto: «Strano come gesto!» e la risposta di Aragorn è: «Un gesto coraggioso». È cambiato il senso della frase.
Nell’originale Aragorn aggiunge un aggettivo alla definizione di Gimli, dice che il gesto di Frodo è stato sì strano, ma anche coraggioso. Nella versione di Fatica Aragorn corregge Gimli, gli dice che il gesto è stato coraggioso, non strano. Non è una sfumatura da poco, perché nella traduzione Aragorn suona sicuro di sé, ha già capito tutto e spiega le cose ai suoi compagni meno avveduti.
Nella versione originale invece suona dubbioso: il suo coraggioso prosegue lo strano di Gimli, Aragorn sta formulando i pensieri in quel momento, sta ancora ragionando, non è sicuro di niente. In tutto questo capitolo il nostro è gravato dai dubbi, si sente in colpa e inadeguato al suo compito.
Libro Cinque, Capitolo 1: «Minas Tirith»
Si tratta di un capitolo complesso, in cui si alternano registri narrativi diversi, che definirei lirico-descrittivo, lirico-drammatico, epico, comico. La resa della traduzione secondo me è altalenante.
L’apertura è totalmente parafrasata, senza motivo apparente: Tolkien ha scritto: «Pippin looked out from the shelter of Gandalf’s cloak», letteralmente Pippin guardò (sbirciò) fuori dal rifugio del mantello di Gandalf». La traduzione è: «Protetto dal mantello di Gandalf, Pippin sbirciò fuori».
Subito dopo c’è: «The dark world was rushing by and the wind sang loudly in his ears». Letteralmente: il mondo oscuro correva/s’affrettava e il vento cantava/fischiava nelle sue orecchie. La traduzione è: «Il mondo tenebrato trascorreva ratto e il vento soffiava sonoro nelle orecchie». Abbiamo il participio passato del verbo letterario tenebrare per tradurre un semplice dark, il verbo trascorrere per un altrettanto semplice rush e soffiava sonoro per sang (passato di to sing, che oltre a cantare, è anche emettere un suono lamentoso o fischiante). L’aggettivo possessivo «his» (suo) non c’è.
Poco più avanti ancora abbiamo «but his memory was drowsy and uncertain», letteralmente ma la sua memoria era sonnolenta e incerta. La traduzione è «ma la memoria, sonnacchiosa, nicchiava».
Nelle prime pagine del capitolo ci sono vari passaggi di questo tipo, con termini letterari o desueti al posto di parole inglesi di uso corrente e cambi della sintassi. Per esempio questo stravolgimento: al posto di «It was twilight: the cold dawn was at hand again», abbiamo «Sul far del giorno ecco di nuovo i primi freddi albori», dove la semplice locuzione it was twilight, (letteralmente era il crepuscolo) concisa e troncata dai due punti, è resa con sul far del giorno, senza i due punti. Il resto è parafrasi.
Quando Pippin e Gandalf entrano nella sala del trono, Tolkien ci dice che il pavimento era «inset with flowing traceries of many colours» e la traduzione è «rabescato di leggiadri motivi variopinti». Rabescato è participio passato del verbo rabescare, derivato da rabesco, forma non comune di arabesco. Al di là dell’anacronismo (non esistevano gli arabi) che si può tranquillamente perdonare, la differenza tra inset e rabescato è notevole. L’uso di inset come verbo è probabilmente poco comune in lingua inglese, ma il suono della parola non credo. Tutt’altra faccenda è rabescato in italiano, che è piuttosto insolito per l’assenza della a.
Tolkien non ci dice cosa è rappresentato sul pavimento, dice solo che c’erano motivi colorati e fluenti (ma poi perché «leggiadri»?). Eppure a me il contesto fa pensare a forme di animali e piante, piuttosto che ai pattern geometrici con cui ci si riferisce con arabesco e i suoi derivati.
Al termine di queste pagine descrittive, la traduzione sembra scorrere con più aderenza al testo e leggiamo di Pippin alle prese con Denethor, con Gandalf, con Beregond e suo figlio Bergil. Fa eccezione la parte descrittiva del paesaggio del Pelennor, quando lo hobbit sta affacciato sulle mura insieme a Beregond. Allora abbiamo gli sbrendoli di nuvole per wisps of clouds (letteralmente ciuffi di nuvole), oppure il deeper gloom a oriente (letteralmente oscurità più profonda) che è reso con tenebrore. E l’hammer stroke (letteralmente : colpo di martello) che diventa una mazzata. E più avanti troviamo girth (letteralmente circonferenza, per indicare la grande pancia dell’obeso Forlong) è reso addirittura con epa.
Opinione Complessiva
Alla luce di questi raffronti, mi sento di dire che la traduzione di Ottavio Fatica non può essere definita «filologica».
L’aggettivo «filologica» è stato utilizzato spesso dai sostenitori della nuova traduzione, (anche da me, inizialmente).
Ma è fuorviante. Basti notare che in tutto il romanzo non compare neanche una nota a piè di pagina scritta dal traduttore.
Se la filologia «è ricerca basata sull’esame di testi e documenti o su notizie storiche», non mi sembra che questa traduzione possa essere definita «filologica».
Una traduzione veramente filologica costerebbe certamente troppi anni di lavoro, non sarebbe un investimento remunerativo per un editore. Ma forse si poteva pensare di suddividere il compito tra più professionisti. Se non era possibile trovare traduttori esperti che fossero anche conoscitori dell’opera di Tolkien, magari si poteva pensare di coinvolgere in maniera più attiva un gruppo di studiosi tolkieniani e addirittura fornire loro un ruolo più attivo (non sia mai).
Gli studiosi di Tolkien non sono quelli che sanno pure se un personaggio «aveva le scarpe allacciate alle cinque del pomeriggio». Semmai sono quelli che sanno perché Tolkien ha scritto quel dettaglio. E dunque perché è fondamentale che quel certo passaggio sia tradotto con grande attenzione.
Capisco benissimo che gli editori sono sul mercato per fare impresa, non beneficienza a una minoranza di nerd che rappresentano una piccola frazione degli acquirenti finali. Ma ho scritto questo articolo per dire cosa penso di questa traduzione. Ed è questo: è il frutto di un’operazione editoriale fatta con l’intenzione di portare sul mercato una versione migliore e più fresca di un long selling, per dargli nuovo smalto, senza però rischiare di imbarcarsi in un’impresa eccessivamente ardita.
Il risultato è buono, paragonato alla vecchia traduzione, su questo bisogna essere chiari. Però non è il meglio che ci si poteva aspettare dopo tanti anni di attesa.
Linguaggio «alto»
Il nuovo traduttore si è sforzato di restituire la gamma dinamica dello stile di Tolkien, che in molti tratti diventa aulico, ma spesso mettendoci del suo, traducendo in modo personale. Riesce ad essere piuttosto fedele nei passaggi più piani, quando lo stile non è alto né basso. Specie quando l’originale sale, invece, tende a personalizzare molto, inserendo arcaismi e termini letterari anche dove non ci sono.
Ci sono parole che il nuovo traduttore usa in modo ricorrente, dando l’impressione che si tratti di stilemi tipici di Tolkien, ma che non hanno corrispondenza nell’originale. Così abbiamo «trascorrere» nel senso di correre attraverso/passare, usato per tradurre «to float», «to pass» o «to flow»; abbiamo «contesto» nel senso di tessuto insieme per tradurre «threaded» e «wrought».
Ho trovato circa 40 ricorrenze di «fello» per tradurre «fell»: è un’ottima traduzione per una parola che Tolkien usa di continuo; ma almeno una volta ho trovato «fello» per «fierce» e una volta «fellone» (che ha la stessa etimologia di fello e che ha significato sostanzialmente sovrapponibile) per tradurre «recreant».
Il termine «vallea» è usato in modo ricorrente, a volte per tradurre «dale», a volte «vale», a volte un normalissimo «valley». Il lettore italiano ha così l’impressione che Tolkien abbia usato una sola parola molto altisonante, quando invece ne ha usate tre, che hanno sfumature diverse.
Troviamo spesso il termine «scalea» al posto dei più semplici «scala» o «scalinata». Per i toponimi («Scalea dei Riombrosi») non è male: esiste il comune di Scalea in Calabria (anche se in quel caso l’etimologia ha a che fare con lo scalo portuale). Ma poi ci troviamo a leggere di re Théoden che scende per una scalea quando i lettori inglesi lo vedono percorrere una normalissima «stair».
Linguaggio «basso»
Quando il linguaggio è popolare (la famiglia Gamgee e altri hobbit «proletari»), a me la nuova traduzione sembra a tratti in imbarazzo. In alcuni casi mette termini letterari in bocca a personaggi che in originale hanno una parlata semplice e sgrammaticata: per esempio il già citato «veglio», oppure «genìa» per tradurre «breed», che letteralmente significa «razza» e che Hamfast Gamgee usa poco elegantemente per definire la famiglia Brandybuck.
Oppure troviamo la parola italiana «tate» (credo inventata) per «taters», termine colloquiale inglese per dire patate. Ma in Italia c’è qualcuno che dice tate per indicare le patate? Eppure anche da noi esistono termini dialettali per le patate. La nuova traduzione ci prova a seguire Tolkien quando scende su un linguaggio basso, con risultati a volte buoni, ma a volte decisamente deludenti.
Le ripetizioni
In alcuni casi, il traduttore sembra non essersi accorto di alcuni dettagli stilistici che hanno un senso nel racconto.
Abbiamo parlato della mancata corrispondenza nella formula con cui i personaggi commentano la morte di Boromir e, centinaia di pagine dopo, quella di suo padre Denethor.
Roberta Capelli ha scritto un interessante saggio breve (nel già citato Quaderno di Arda – Volume II), in cui spiega che Tolkien fa un uso molto molto attento delle ripetizioni: le sfrutta per creare collegamenti tra scene parallele. Per esempio tra la fine del Capitolo 5 e l’inizio del Capitolo 6 del Libro Uno, in cui l’avverbio «suddenly» (improvvisamente) viene usato come «spia» del parallelismo tra il sogno di Frodo (fine del Capitolo 5) e il luogo in cui si trova al risveglio (inizio Capitolo 6): Frodo sogna di essere al buio, di vedere suddenly un lampo e sentire un tuono; poi suddenly si sveglia in una stanza buia, vede la luce della candela di Merry e sente il suono della sua mano che bussa. In pratica abbiamo un parallelismo suddenly-buio-luce-rumore. Nella nuova traduzione questo «suddenly» è stato reso prima con «d’un tratto» e poi con «all’improvviso» e così manca la chiave di collegamento tra le due scene.
È probabile che oltre a questi due ci siano molti altri usi creativi della ripetizione sparsi lungo il romanzo, che sono andati persi in traduzione.
10 – Conclusioni
Dunque, qual è il mio parere sulla nuova traduzione del Signore degli Anelli fatta da Ottavio Fatica?
Una nuova traduzione doveva essere fatta, lo abbiamo detto. La vecchia traduzione Alliata-Principe è un importantissimo pezzo di storia della letteratura fantastica in Italia e spero sinceramente che un domani possa tornare a disposizione degli appassionati. Ma era del tutto inadeguata all’importanza che ha assunto Il Signore degli Anelli dopo mezzo secolo, per tutti i motivi che abbiamo spiegato.
La nuova traduzione del Signore degli Anelli è migliore della vecchia?
Certamente sì, senza ombra di dubbio. Si legge con piacere ed è stata fatta con l’intenzione di fornire ai lettori italiani un’esperienza di lettura simile a quella dei lettori anglofoni che leggono il testo originale, anche se con risultati non sempre buoni. C’è dietro una ricerca su nomi e toponimi molto attenta a restituire i significati originali (a differenza della vecchia). C’è stato il supporto degli esperti italiani (nella fattispecie da parte di Giampaolo Canzonieri per l’AIST).
La nuova traduzione del Signore degli Anelli ha dei difetti?
Sì, ce li ha.
Sono difetti gravi?
Dipende.
C’è una ristretta minoranza di appassionati che rileggono il romanzo molte volte e ne indagano le sfumature trovando sempre cose nuove. Ma la maggior parte dei lettori legge Il Signore degli Anelli una sola volta nella vita, forse due, e vuole solo lasciarsi trasportare dal racconto.
Ciò che può infastidire però anche i lettori meno puntigliosi è il fatto che in questa traduzione si trovano non di rado termini altisonanti, rari e letterari che non hanno corrispondenza nell’originale, che suonano forzati e che creano degli inciampi nella lettura, interrompono l’ipnosi generata dal racconto. È così anche l’originale? Posso sbagliare, ma a me non sembra. Nei passi che ho confrontato Tolkien mi sembra usare termini «difficili» sempre in maniera mimetica rispetto al racconto o come «gioco» con il lettore.
Maddai! È proprio necessaria tanta attenzione ai dettagli?
Il Signore degli Anelli non è un libro qualsiasi. Non è nemmeno un capolavoro come altri. È un capolavoro che ha dato origine a un genere letterario e che conta schiere di fan in tutto il mondo. Alcuni di questi fan sono studiosi di alto livello (alcuni sono accademici) che hanno prodotto tantissimo materiale di critica letteraria di grande spessore su Tolkien e le sue opere.
Perciò secondo me sì ci vorrebbe molta attenzione ai dettagli.
Si poteva fare diversamente?
Forse no, non lo so.
Bompiani ha proposto il lavoro a un traduttore esperto e di chiara fama. Ma un traduttore che non conosceva Tolkien e non lo stima particolarmente. Ha chiesto una consulenza alla più importante associazione tolkieniana in Italia, ma senza darle alcun potere decisionale.
Il risultato è una buona traduzione, più moderna, più professionale e più efficace della vecchia. Ma non è una traduzione filologica.
In definitiva
Credo di aver espresso il mio parere.
Ribadisco che la nuova traduzione è un grosso passo avanti per la conoscenza di Tolkien in Italia. Ma, da appassionato, penso che sia stata anche, almeno in parte, un’occasione persa. Si poteva osare di più, coinvolgendo più persone e soprattutto sfruttando meglio la folta comunità di appassionati.
Che Tolkien abbia ancora oggi un fandom è un enorme valore aggiunto, non qualcosa di cui ridacchiare.
A partire dal febbraio 2020 ho deciso di filtrare i commenti: se non sei d’accordo con quello che ho scritto, devi entrare nel merito delle questioni, dimostrandomi di aver letto la nuova traduzione.
Altrimenti il commento non te lo pubblico.
_____________________
 Mia figlia ha cinque anni, non sa ancora leggere e io e sua madre, come fanno molti genitori, le raccontiamo delle storie.
Mia figlia ha cinque anni, non sa ancora leggere e io e sua madre, come fanno molti genitori, le raccontiamo delle storie.